Pubblichiamo l’intervento della nostra redattrice, invitata il 28 novembre scorso – presso la Biblioteca delle Donne di Palermo – a discutere di Giulia Mafai (costumista, scenografa e scrittrice), in occasione della presentazione del romanzo postumo AGENDA ROSSA: “una storia partigiana e di militanza, giustizia, libertà, emancipazione e femminismo”. Nel corso della iniziativa è stata ricordata l’artista Sabina De Pasquale, figlia di Simona Mafai sorella di Giulia_
 Giulia Mafai (Roma, 1930 – 2021), costumista e scenografa, nella sua Storia del costume dall’età romana al Settecento (Skira, 2011) illustra mode e ricostruisce epoche e società contraddistinte da convinzioni e contraddizioni che illuminano anche i grandi eventi, le svolte e le tragedie che hanno segnato l’umanità in occidente dal III secolo a. C. al XVIII secolo d. C.
Giulia Mafai (Roma, 1930 – 2021), costumista e scenografa, nella sua Storia del costume dall’età romana al Settecento (Skira, 2011) illustra mode e ricostruisce epoche e società contraddistinte da convinzioni e contraddizioni che illuminano anche i grandi eventi, le svolte e le tragedie che hanno segnato l’umanità in occidente dal III secolo a. C. al XVIII secolo d. C.
E così, ad esempio, durante le crociate, nelle quali vennero reclutati uomini di tutte le classi, le dame medievali presero il controllo di ricchezze e feudi e, inoltre, iniziarono a dilettarsi con la lettura e ad esercitare la scrittura, tralasciando attività prettamente femminili quali il fuso e la conocchia. In verità molte dame ricoprivano già da tempo posti di potere, ad esempio le badesse di conventi e monasteri. Si trattava di donne istruite e colte che studiavano i classici della letteratura oltre che i testi sacri. D’altra parte negli stessi anni cambiò l’iconografia dell’Annunciazione, in cui Maria viene sorpresa dall’angelo Gabriele con la bibbia in mano o sul leggio, anziché mentre fila la porpora.
A conferma di questi cambiamenti le rappresentazione tombali del secolo XIII mostrano “cavalieri armati di tutto punto” mentre le dame sono “ritratte nei loro abiti ricchi, ben acconciate, serene nella morte, e per la prima volta” recano “fra le mani un libro aperto”.
Il lavoro di costumista ha consentito a Giulia Mafai di mettere assieme le conoscenze sartoriali, tradizionalmente femminili, con la ricerca e lo studio “su un territorio per così dire onnivoro” che induce a prendere in mano libri di storia, volumi d’arte, biografie, romanzi ma anche a consultare “studi archeologici” e “atti legislativi e notarili”. Nonostante tanto impegno per capire mode passate e presenti, esse spesso sfuggono a ogni logica e razionalità.
Probabilmente l’essere umano supplisce ad un corpo privo di colore e di ornamenti con l’abito. “La natura – osserva Mafai – non è stata generosa con l’uomo ed egli ha cercato in infiniti modi di mascherare l’imbarazzo della propria indifesa nudità: non ha piume, né squame, non possiede pelliccia, non ha zanne e nemmeno coda”. È questa la ragione per cui intorno al 1100 fecero la loro comparsa le ingombranti maniche delle dame medievali? Maniche per quali erano necessari metri e metri di stoffa: con ciascuna di esse sarebbe stato possibile realizzare un abito intero. “Il popolino” indignato le chiamava maniche stanche per “l’inutile spreco di tessuto”, e così sono menzionate negli atti notarili. Insieme alle lunghe code, furono bersaglio delle leggi suntuarie, e pertanto venne vietato di utilizzare più di tre metri per manica e per lo strascico non più di cinque. Condannate anche dal clero che non disdegnava però, almeno nelle alte cariche, di vivere nel lusso e nello sfarzo: vescovi e abati abitavano “in sontuosi palazzi” disponendo di “servi e schiavi” e molto spesso di “pubbliche concubine”.
La moda delle grandi maniche e delle code mise a dura prova anche le ricche signore gravate dal pesante fardello di stoffa, tanto che “Margherita di Francia il giorno del suo matrimonio, indossava una veste così ricca e pesante da dover essere condotta in braccio sino all’altare”. Una moda smisurata e sfrontata dinanzi alla gran massa di umanità che versava nella più vergognosa miseria e d’altra parte anche ai giorni nostri assistiamo alla superbia di donne e uomini che sguazzano nel lusso mentre tante/i vivono nell’assoluta indigenza.
Ma tornando alla storia del costume raccontata da Mafai è interessante citare un altro eccesso nella storia del costume, questa volta maschile, che mostra anche l’osceno, il grottesco e il bestiale. Si tratta dell’abito mercenario delle truppe di lanzichenecchi che si affacciarono alla storia a seguito di Carlo V e che nel 1527 saccheggiarono Roma. Un esercito di uomini senza scrupoli al soldo del maggior offerente pronti a passare da un campo di battaglia all’altro per danaro. Senza alcuna divisa, ciascuno di questi masnadieri si rivestiva con i capi del bottino guadagnato durante le scorrerie e si compiaceva di indossare anche indumenti femminili riadattandoli al proprio corpo, mentre dalle variopinte calze lasciavano in vista la braghetta che in breve tempo si ingrandì e gonfiò, diventando una vera e propria “tasca riempita di bambagia, di segatura o di fieno, fino ad assumere l’esagerata forma di un fallo […] arricchita da fiocchi, nastri e campanelli […] così grande da essere utilizzata come borsa ausiliaria dove tenere nascoste le monete e i gioielli più preziosi”. Potevano essere scambiati per “un esercito di teatranti buffoni” e invece questi soldati di ventura “agghindati come enormi galli cedroni”, dove passavano, lasciavano “distruzione, lacrime e morte”. Una descrizione che tristemente restituisce le scene di efferata violenza delle guerre odierne che vediamo scorrere in TV e nei social.
Questo abbigliamento trasandato e scomposto, riadattato, divenne moda per re, nobili e cavalieri che indossarono corti calzoni a bande a simulare i tagli lanzichenecchi mentre la conchiglia mostrava “un astuccio penico simile a quello della soldataglia”.
Nonostante si trattasse di uno stile a dir poco discutibile “i benpensanti, sempre disponibili a difendere la morale”, si guardarono bene da metterla in discussione. Tuttavia, tanta sfrontatezza indignò alcune dame, come quelle di Modena che le leggi condannavano se solo lasciavano “intravedere i piedi calzati” e le caviglie da sotto le gonne che si erano fatte ampie e prive di code. 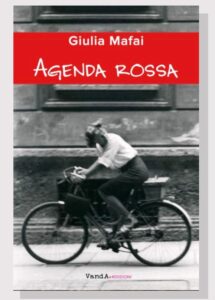 Fu Elisabetta Tudor, regina d’Inghilterra, ad accorciare, tra le prime, la veste in modo da mettere in mostra le caviglie che sapeva di avere eleganti e sottili, rivestite dalle preziosissime calze nere realizzate ad ago nei laboratori di Napoli e Venezia. Le calze, in questo frangente, erano un capo esclusivo di re e regine ma alla fine del Cinquecento, con l’invenzione di una macchina per realizzarle, la platea di chi poteva acquistarle si allargò, rimanendo comunque un elemento d’abbigliamento costoso e indossato da dame e cavalieri dei più elevati ranghi.
Fu Elisabetta Tudor, regina d’Inghilterra, ad accorciare, tra le prime, la veste in modo da mettere in mostra le caviglie che sapeva di avere eleganti e sottili, rivestite dalle preziosissime calze nere realizzate ad ago nei laboratori di Napoli e Venezia. Le calze, in questo frangente, erano un capo esclusivo di re e regine ma alla fine del Cinquecento, con l’invenzione di una macchina per realizzarle, la platea di chi poteva acquistarle si allargò, rimanendo comunque un elemento d’abbigliamento costoso e indossato da dame e cavalieri dei più elevati ranghi.
Le calze sottili che oggi chiamiamo collant, non più di seta ma del sintetico e inquinante nylon, prodotte in grande scala, sono alla portata di tutte noi ma ancora nella prima metà del secolo scorso erano oggetto del desiderio di tante donne, come Adua, staffetta partigiana e in seguito funzionaria del partito comunista che, di nascosto dalla madre, le indossa la prima volta che si reca a teatro nel romanzo storico Agenda rossa (Vanda Edizioni, 2021) di Giulia Mafai, in cui le annotazioni di costume e moda danno corpo alla storia d’Italia del XX secolo.










