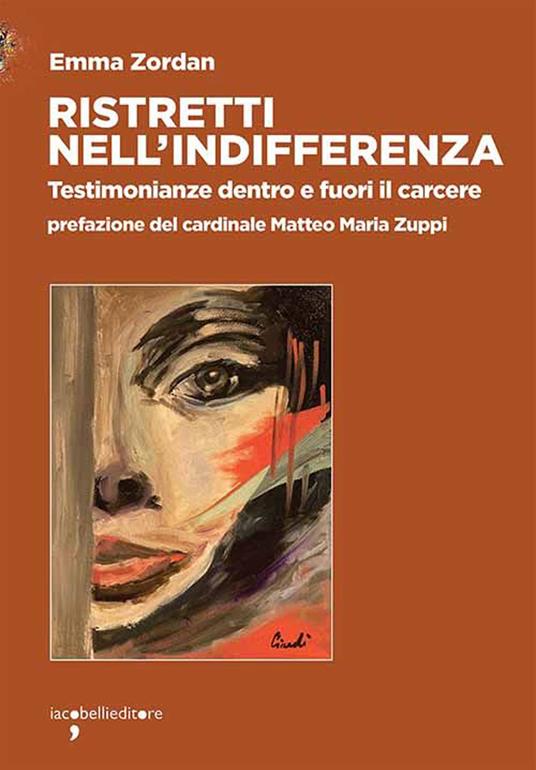Dei penitenziari sappiamo poco e non abbiamo intenzione di saperne di più. Però ne parliamo, con frasi slogan che dovrebbero racchiudere la soluzione di ogni male, ripulire le strade dalla delinquenza, garantirci la sicurezza: «Bisogna inasprire le pene», «Chiuderli e buttare la chiave», «Marciscano in galera», «La colpa è del buonismo, il 41bis va esteso a tutti i ladri e gli assassini», «In carcere devono soffrire, non è mica un albergo».
I più sono convinti, spesso in buonafede, che segregare chi ha trasgredito le regole e trattarlo con la massima durezza possibile possa funzionare come deterrente, quando non soltanto è provato che non è così, ma “massima durezza” e “rieducazione” non sono espressioni che vanno d’accordo. Il problema è che alla rieducazione e quindi al reinserimento nella società non si crede, quasi fosse un’utopia di anime belle. La realtà è la violenza crescente, il senso costante di pericolo che proviamo tutti noi, perché se una volta (si dice, e in parte è vero) i ladri erano professionisti, oggi puoi trovarti chi per quattro spicci ti ammazza, chi entrando in una casa dove ci sono anziani e non trovando quello che sperava li riduce in fin di vita a forza di botte. E allora via, tutti al gabbio. Senza se e senza ma. Ammassati e chissene importa se si suicidano, anzi, meglio (54 dall’inizio dell’anno ad oggi, a cui vanno aggiunte 71 morti per cause non accertate, malattia, omicidio e overdose, senza dimenticare i suicidi di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, un’altra tragedia di cui non si parla mai).
Inascoltate le voci che arrivano da chi il carcere lo conosce. Operatori istituzionali, volontari, e naturalmente parenti e amici dei carcerati e carcerati stessi. Tra loro, qualunque sia l’orientamento politico, il rozzo schieramento destra giustizialista/sinistra perdonista salta. Aver visto, aver vissuto sia pure indirettamente, porta tutti a un cambiamento di prospettiva. Si propone di fare proprio questo, la suora Emma Zordan, da anni volontaria alla cassa di reclusione di Rebibbia: dare voce a chi è coinvolto, a chi sa di cosa parla e non per sentito dire. Il punto su cui Zordan insiste, tanto da averlo usato nel titolo del libro e averlo proposto come stimolo di riflessione agli intervistati, è l’indifferenza: Ristretti nell’indifferenza. Testimonianze dentro e fuori il carcere (ed. Iacobelli) è un grido sommerso, dolente e continuo contro la mentalità comune che, come sottolinea il cardinal Matteo Maria Zuppi nella prefazione, pretende non solo il diritto di essere indifferente, ma anche un sistema che non faccia vedere i problemi, li nasconda, se possibile li cancelli. Il carcere come mondo parallelo, per cui ci sentiamo, noi che ne siamo al di fuori, perfettamente abilitati a disconoscerlo, a negarne qualunque possibile relazione col nostro, il “mondo dei giusti”. L’indifferente, osserva Zuppi, è convinto di non avere fatto niente di male, invece l’indifferenza genera degli inferni, perché il male non è indifferente, anzi, prolifica negli spazi lasciati liberi dal non amore e semina conforto, violenza, disillusione, odio.
Nel libro sono diciannove le voci dei detenuti, cinque di quelli condannati al fine pena mai, due dei detenuti in semilibertà, due ai domiciliari, due immigrati, quattro ex detenuti.
Aniello Falanga, detenuto: «Non sono né vivo né orto. Peggio! Sono uno che viene lasciato morire lentamente nella dimenticanza, nella totale solitudine interiore … L’ergastolano non vive, mantiene in vita un corpo che non gli appartiene più perché è diventato proprietà della giustizia». Antonio Di Sero, detenuto, racconta dell’umiliazione subita all’ospedale Pertini in cui, nonostante la temperatura rigida, è stato portato in pantofole e accompagnato da due agenti della Polizia Penitenziaria come da regolamento, ed è stato mortificato dagli sguardi della gente di passaggio o in attesa di visita, «sguardi precisi che sapevano di diffidenza celata sotto una totale indifferenza». Alfonso de Martino, fine pena mai, si domanda perché il Signore non voglia prenderlo con sé, e Marco Fagiolo, anche lui fine pena mai, conclude che l’unica cosa da fare è gettare la spugna con la ferma decisione di non lottare, non fare più niente, lasciarsi andare. Racconta anche che uno dei motivi di scoramento è l’indifferenza evidente in ogni atto burocratico, in primis nei tempi di attesa per la presentazione della relazione sul comportamento del recluso, necessaria per accedere ai benefici di legge: «Sono tempi che sfiancherebbero chiunque, ma che i detenuti sono costretti a sopportare con apprensione ed estrema pazienza, pazienza che a volte viene meno e può portare a compiere atti di autolesionismo, se non gesti estremi come il suicidio … Suicidi, per assurdo, anche loro destinati alla più completa indifferenza». Fagiolo compie anche un passo successivo: «È certamente giusto lamentarsi della tanta indifferenza che ci circonda. Ma sarebbe altrettanto giusto fare un mea culpa proprio per l’insensibilità provata verso gli altri, verso le vittime … maturare la consapevolezza della sofferenza inferta direttamente o indirettamente, sia alle vittime dei reati che ai nostri stessi familiari: altrimenti, a cosa sarebbe servito espiare la pena?». Appunto. Davvero si può ritenere che questa consapevolezza, obiettivo della “rieducazione”, passi attraverso sofferenze fisiche e morali che si aggiungono alla privazione della libertà? Una rivelazione amara quella di Michele Cuffari, fine pena mai: «Ho visto i più buoni diventare indifferenti e le vittime diventare carnefici nell’indifferenza. Con il passare del tempo, l’indifferenza ha lentamente fatto il suo ingresso anche in carcere, un luogo che dovrebbe essere l’esempio della solidarietà».
Antonella Rasola, direttrice del carcere di Rebibbia, non ha dubbi sulla strada da seguire: «Sappiamo bene che l’approccio giusto da adottare è quello di favorire quanto più i contatti con la società civile, mettendo in atto le condizioni per offrire alle persone detenute le possibilità opportunità inclusive, attraverso l’accesso al lavoro, alla formazione professionale, allo studio, allo sport; perché il tempo trascorso in carcere non rimanga vuoto e sospeso, ma abbia un senso, divenga risorsa preziosa da cui attingere per affrancarsi e divenire persone nuove». E prima di tutto: «È necessario che fuori si sappia cosa accade dentro».