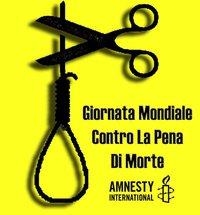
Il 29 giugno del 1972 la Corte Suprema degli Stati Uniti decise, con la sentenza Furman v Georgia e le compagne Jackson v Georgia e Branch v Texas, che la pena di morte americana non era conforme alla Costituzione statunitense.
Con le sue nove opinioni e le sue 233 pagine Furman v Georgia è la più lunga e forse la più incasinata delle sentenze della Corte Suprema, ma non ha dichiarato la pena di morte incostituzionale in quanto tale, ma solamente il modo “arbitrario e capriccioso” con cui essa era amministrata. Di certo è stata la più illusoria delle sentenze.
Quel giorno gli abolizionisti americani credettero che il loro paese fosse tornato all’avanguardia come lo era nel 1847, quando il Michigan, battendo San Marino e la Repubblica Romana, divenne la prima giurisdizione stabilmente abolizionista. Non per nulla nel ’72 la Francia aveva ancora le esecuzioni, l’Inghilterra una traballante abolizione e il Canada avrebbe abrogato la pena di morte solo quatto anni dopo, negli stessi giorni di Gregg.
Prima di Furman la Corte Suprema si era raramente occupata di pena di morte e non l’aveva mai messa in discussione, ma, dopo la sentenza McGautha (1971), i tempi sembravano maturi. Gli omicidi e conseguentemente esecuzioni e condanne a morte erano sistematicamente diminuiti in tutti i trent’anni precedenti e nel 1967 c’era stata l’ultima esecuzione pre-Furman. Il Movimento Abolizionista era fiducioso nella prossima abolizione del patibolo per via giudiziaria. Poco prima era stata la Corte Suprema della California a decidere la fine della pena capitale in quello stato e si riteneva che la partita stesse per chiudersi in tutti gli Usa. La sentenza Furman fece credere che la pena di morte americana avesse terminato il suo cammino e invece fu proprio a partire da essa che riprese con una violenza inaspettata.
La Corte aveva deciso che l’illimitata discrezione delle giurie nel deliberare la pena di morte violasse l’ottavo emendamento, ma solo i giudici Brennan e Marshall pensavano che la pena capitale fosse di per sé contraria alla Costituzione. Gli altri sette decisero che la dottrina “death is different” fosse consona agli “evolving standard of decency that marked the progress of a maturing society.” Furman ci ha lasciato alcune frasi famose che sono entrate nell’uso comune e non solo in quello giudiziario come “arbitrary and capricious”, “wantonly and freakishly imposed”, “struck by a lighning”, ma è con Gregg v Georgia del 2 luglio 1976 che ci dobbiamo confrontare
Se la reazione alle sentenze Gideon (1962) e Miranda (1966) fu durissima, e continua ad esserlo, quella a Furman fu a dir poco rabbiosa. La sentenza fu definita “a license for anarchy, rape and murder” e rigettata da un’opinione pubblica spaventata dalla guerra del Viet Nam, dalla crisi economica e sociale, dalle rivolte nei ghetti, dal crescere di crimine e omicidi e dalla sua stessa violenza. Alcuni uomini politici (come il presidente Nixon e l’allora governatore della California Regan) si posero alla testa dei forcaioli e non parve loro vero di avere una soluzione per curare tutti i mali dell’America: la forca. Non fu per caso che l’economista Isaac Erlich pubblicasse “The Deterrent Effect of Capital Punishment” in cui, dopo avere torturato a lungo i fatti, “dimostrava” che ogni esecuzione avrebbe salvato la vita di otto persone innocenti. Il suo saggio ebbe un effetto travolgente sull’opinione pubblica e poco contò che venisse poi distrutto dagli esperti e dai fatti.
I parlamenti di Florida e Utah fecero gli straordinari e approvarono nuove leggi capitali entro il 1972. Alla fine dell’anno successivo gli stati con un nuovo sistema di morte erano 15 e nel 1976 ben 35. Quattro anni dopo Furman i condannati a morte erano già 460 e la Corte Suprema, senza averne la più piccola prova, decise con Gregg e le sentenze compagne che le nuove leggi capitali rispettavano le indicazioni fornite da Furman. Secondo la Corte quindi la pena capitale americana non era più applicata in maniera arbitraria e capricciosa ed essere condannati a morte non era più un caso imprevedibile come essere colpiti dal fulmine. Era il 2 luglio 1976. Pochi mesi dopo, il 17 gennaio 1977, Gary Gilmore si consegnava volontariamente al plotone d’esecuzione.
Da Gregg in avanti la giurisprudenza della Corte suprema prevede la pena di morte solo per l’omicidio con aggravanti elencate dalla legge. Prima di Furman si poteva essere condannati a morte per qualsiasi tipo di omicidio e, in alcuni stati, anche per rapina, rapimento e stupro. Ora occorre quello che Rick Halperin chiama “homicide with something”. L’assassinio deve avere alcune aggravanti che lo distinguano dall’omicidio non capitale: essere un omicidio multiplo o particolarmente depravato, ovvero commesso per denaro oppure, ed è quello che fornisce l’80% delle condanne a morte, essere occorso durante lo svolgimento di un altro crimine, essere cioè un felony murder. Non si può essere condannati a morte per stupro (Coker 1977 e Kennedy 2008) o per rapimento (Eberheard 1977) e la pena capitale non può essere obbligatoria (Woodston e Roberts 1976), non si possono condannare i minorenni (Roper 2005), i pazzi (Ford 1986) e i minorati (Atkins 2002). Il processo deve essere biforcato: con un processo “normale” in cui si decide il verdetto: colpevole o non colpevole, seguito da un nuovo dibattimento in cui si bilanciano aggravanti e attenuanti e con la giuria (Ring 2002) che decide della vita del condannato.
Dopo il 1972 non aumentarono solo le condanne a morte. Gli Stati Uniti iniziarono il più grande esperimento di imprigionamento di massa dai tempi di Stalin. Aumentarono il numero dei reati passibili di prigione, allungarono le condanne e misero in galera più gente possibile. Negli anni successivi a Furman si assistette all’incontrollata crescita di quello che oggi chiamiamo l’American Gulag. I prigionieri nelle prigioni statali e federali passarono dai 300.000 del 1980 al 1.600.000 di oggi. L’insieme dei detenuti e di chi è in probation o parole crebbe da un totale di meno di 2 milioni agli attuali 7 milioni abbondanti e non è certamente un caso se a questo corrisponde l’aumento esponenziale dell’ineguaglianza sociale americana.
Se ai 2,35 milioni in prigione e ai 5 cinque in parole e probation, aggiungiamo i 4 milioni che hanno perso il diritto di voto (con gravi conseguenze sia per loro che per i risultati elettorali), i bambini che hanno almeno un genitore in prigione (1,7 milioni), i moltissimi on bail che aspettano il giudizio e quelli che hanno difficoltà a trovare lavoro per via della fedina penale sporca, vediamo che l’Incarceration Nation, ha creato una Incarcerated Nation di 15 milioni di persone, un ventesimo della popolazione americana. Metà abbondante degli stati rappresentati alle Nazioni Unite ha una popolazione inferiore.
Oggi dopo almeno 750.000 omicidi, 8.000 condanne a morte e 1.400 esecuzioni; dopo avere speso decine e decine di miliardi di dollari nella pena capitale e dopo che due generazioni di abolizionisti hanno fatto i capelli bianchi su centinaia di migliaia di sentenze delle corti statali e federali, dovremmo avere capito che la guerra alla pena di morte si combatte nelle aule di giustizia e in quelle parlamentari, ma che si vincerà solo nei cuori e nelle menti della gente.
Claudio Giusti, su gentile richiesta dell’amico Giuseppe Lodoli.
29 giugno 2014
P.S.
“Sono passati vent’anni da quando questa Corte [Suprema] proclamò che la pena di morte può essere imposta solo ed esclusivamente in maniera equa e con una ragionevole coerenza (…), [ma] nonostante gli sforzi degli Stati e delle corti per escogitare formule legali e regole procedurali adatte a raggiungere questa impegnativa sfida, la pena di morte rimane intrisa di arbitrarietà, discriminazione, capriccio ed errore. (…)
Supreme Court Justice Blackmun , dissenting in Callins v Collins, February 22, 1994









