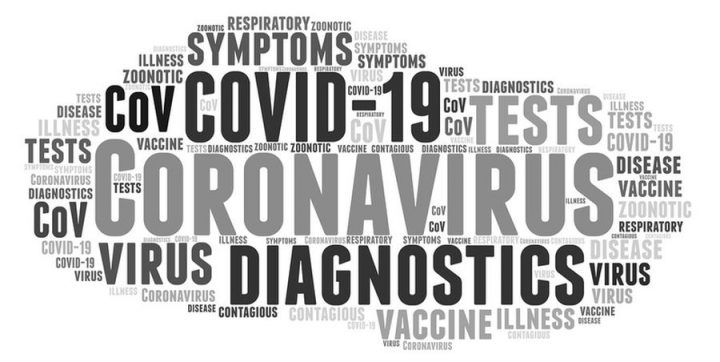Le parole possono fare male e discriminare per sempre. Con i social network e la memoria eterna del web (in certi casi, infatti, non c’è diritto all’oblio che tenga) i nomi legati alle epidemie e alle malattie più in generale possono distruggere intere comunità e alimentare stereotipi e pregiudizi. Con il coronavirus, questa volta, non si è ripetuto l’errore dell’asiatica o della mucca pazza: nel primo caso si è macchiata la popolazione di un intero continente, nel secondo, invece, si è procurato allarme in un intero mondo di consumatori, che hanno messo in ginocchio tutte le produzioni di bovini. Così, quella che si sarebbe potuta chiamare ‘la febbre di Wuhan’ è diventata una più asettica Covid-19, un acronimo che sta per Corona (Co-), virus (Vi-), disease (-D , in inglese malattia) e 19, come l’anno in cui è stata individuata (2019). La paternità di questo nome è dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha voluto evitare che si ripetessero i casi precedenti di ‘razzismo linguistico’ applicato alla sanità. C’è una differenza con Sars-Cov-2, invece: questo è il nome del virus che scatena la Covid-19 (e anche in questo caso si tratta di una sigla, che sta per Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2).
Ma quali sono state le malattie della discriminazione linguistica? Vediamole.
A fine Ottocento causò un milione di persone la prima asiatica (che portò intorno al milione di morti). Era invece il 1918, proprio mentre stava per finire la prima guerra mondiale, quando un’epidemia influenzale uccise milioni di persone nel mondo: era la spagnola. Si parla di 500 milioni di contagiati in tutto il pianeta con morti stimate tra le 50 e i 100 milioni. In una popolazione mondiale di 2 miliardi di persone fu un vero colpo basso. Tutto non nacque in Spagna, però. Il nome deriva dalla ribalta internazionale che venne data dai media spagnoli perché, in Europa, erano gli unici che non avevano censura e che iniziarono subito a trattare la notizia.
Nella piena seconda ricostruzione post-bellica, negli anni che per l’Italia segnarono il boom economico, fu la volta della seconda asiatica, nel 1957. Nata anche questa in Cina, come il Covid-19, si stimarono tra un milione e 4 milioni di morti. Passano dieci anni e nel 1968 arriva la Hong Kong. Negli anni Duemila si commise un altro errore: dare i nomi di animali. Così diventa “mucca pazza” la malattia di Creutzfeldt-Jakob, poi l’influenza suina, poi quella aviaria. Ma c’è stata anche la Mers (Sindrome respiratoria del Medio Oriente), Ebola (il cui nome deriva da un fiume della Repubblica Democratica del Congo), e prima ancora la malattia di Lyme (che riprende il nome da una città del Connecticut), la febbre della Rift Valley, l’encefalite giapponese, la West Nile.
Oggi, dopo tutta questa esperienza, l’Oms, ha precisato che “il nome da utilizzare per riferirsi a una nuova malattia deve consistere in termini descrittivi generici, in base ai sintomi, a coloro che colpisce, alla sua gravità o stagionalità”. Dunque, addio a riferimenti geografici o a popolazioni. Perché tutto questo? I mass media hanno necessità di semplificare linguaggi, perché è nell’essenza stessa del loro essere. Semplificare, però, non vuol dire estremizzare né, tantomeno, partecipare a un imbarbarimento del linguaggio. La via di mezzo è la strada lanciata dall’Oms per Covid-19: una sigla facile da ricordare e incapace di creare stereotipi razzisti. Anche se poi, tra la gente, il Covid-19 è il Coronavirus: è imparentato col raffreddore ma mette più paura.