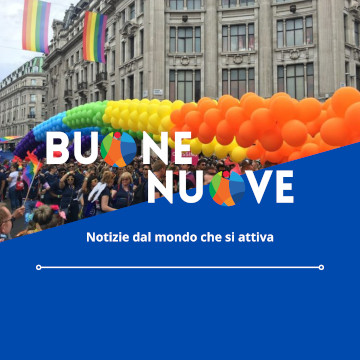La vicenda tristemente nota della morte violenta di Giulia Cecchettin, ventiduenne di Padova uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ha trovato un primo grado di risoluzione nella sentenza depositata dalla Corte d’Assise di Venezia in data 8 aprile 2025. La pronuncia ha suscitato l’indignazione generale a causa della mancata attribuzione dell’aggravante della “crudeltà” ad opera dell’organo giudicante, che ha comminato per Turetta la pena dell’ergastolo.
Il reo confesso, infatti, ha inferto alla ragazza 75 coltellate al fine di provocarne la morte. Un numero enorme, interminabile e difficile da concepire, come dimostra lo spopolare di video sui social che hanno fatto da coda alla pubblicazione della sentenza e che evidenziano l’entità e la durata del gesto, rapportandolo alla componente maligna ed efferata che ha caratterizzato questo (ennesimo) femminicidio.
La forte reazione emotiva a livello collettivo che ha accolto la decisione di non conferire l’aggravante della crudeltà è da registrarsi come dato particolarmente interessante, soprattutto perché collegata alla formulazione delle motivazioni addotte dalla Corte d’Assise.
Si legge infatti nella sentenza: “Nel caso di specie, l’aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene che sia stato, per Turetta, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistrazione dell’ultima fase dell’azione omicidiaria, l’imputato ha aggredito Giulia Cecchettin attingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca.
Non si ritiene che tale dinamica, come detto certamente efferata, sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell’imputato, ma essa sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e “pulito“, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia “non c’era più”.
Fatto un doveroso richiamo al contenuto della sentenza, si rende opportuna un’analisi sintetica sul piano giuridico. Dal punto di vista tecnico la crudeltà è intesa come “condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole” (cfr. p. 130 della sentenza stessa).
Infatti, a detta della Corte, la crudeltà non appare integrata dalla fattispecie: “(…) Non vi sono elementi che consentano di individuare indici di incrudelimento, idonei a integrare i presupposti dell’aggravante della crudeltà come definiti dalla giurisprudenza di legittimità: così, ad esempio, l’aver bloccato e silenziato la vittima con il nastro adesivo è circostanza funzionale al delitto e rientra nell’iter necessario per portare a compimento l’azione omicidiaria”.
L’analisi della giurisprudenza di merito, per quanto la vicenda possa ritenersi suscettibile di sfumature interpretative diverse e alternative a quelle fornite, potrebbe apparire abbastanza solida dal punto di vista meramente tecnico-argomentativo, stando anche alla ricostruzione dei fatti supportati dall’istruttoria. Il concetto di crudeltà in senso giuridico è, infatti, connotato in modo tale da prevedere estremi di integrazione piuttosto specifici ed univoci (elemento caratterizzante e strutturale della branca penalistica stessa). In particolare si può ritenere che, rispetto all’intenzionalità di fare “scempio” del corpo della ragazza, la struttura logico-argomentativa della sentenza in punto di conferimento dell’aggravante abbia una propria validità. Validità, secondo l’opinione di chi scrive, ad ogni modo parziale: Turetta infatti, come qualunque femminicida, ha proiettato una profonda oggettificazione di Giulia Cecchettin, disumanizzandola e non riconoscendola come essere libero e senziente. Proprio per questo non si può desumere la certezza che la furia omicida da lui dimostrata non fosse, piuttosto, riconducibile al fenomeno dell’overkilling, (come ha fatto notare la sorella di Giulia, Elena Cecchettin). Si parla di “overkilling” per indicare la condotta omicida di chi infligge un numero di colpi (potenzialmente) mortali molto alto, mosso dalla rabbia e, soprattutto, dalla paura che la vittima possa sopravvivere. Fenomeno, purtroppo, non ancora enucleato dalla nostra giurisprudenza come avente rilevanza giuridica di aggravante, in quanto prevalentemente studiato solo dal punto di vista etologico e sociologico (per quanto estremamente ricorrente nei casi di violenza di genere e intrafamiliare).
Ricomposto il quadro penalistico, emerge, in modo del tutto paritario e distinto, il piano semantico, fortemente impattato dalla formulazione linguistica del passaggio della sentenza.
Il primo e fondamentale elemento da rilevare è il fatto che il giudice parli di assenza di “deliberata scelta dell’imputato”, contraddicendo parzialmente quanto espresso in precedenza rispetto al carattere di risolutezza del gesto compiuto dal Turetta. Usare il termine “intenzionalità” rispetto a un omicidio già dichiarato efferato e premeditato, per quanto evidentemente riferendosi alla condotta della crudeltà, risulta quantomeno fuorviante. Infatti, da un punto di vista puramente logico e a prescindere che si voglia ritenere il fatto come configurante o meno l’aggravante giuridica della crudeltà, l’atto di infliggere settantacinque coltellate avrebbe dovuto essere chiaramente delineato dalla formulazione del giudice come una scelta. Definire un atto “non intenzionale” in termini tanto generici significa, di fatto, impedire di qualificare la violenza, a qualunque grado, come atto intenzionale. Con l’immediato e spaventoso rischio di legittimare di riflesso l’assenza di un’intenzionalità della “nonviolenza”, intesa come l’attitudine umana a superare la violenza interna ed esterna.
Se si riconosce infatti alla magistratura un ruolo tecnico, non si può neanche sottovalutare, sul piano dell’influenza sociale, l’importanza per la stessa di promuovere un grado di sensibilizzazione adeguato, anche a fini preventivi. Messaggio che, data la gravità e la sensibilità del tema dei femminicidi nel nostro Paese, necessita di un recepimento urgente da parte della popolazione (anche di quella “profana” e/o digiuna di nozioni penalistiche). Se, infatti, il diritto vivente si costruisce sulla realtà fenomenologica, nondimeno anche quest’ultima può risultare da esso influenzata. La magistratura detiene infatti l’enorme potere e la delicata funzione di rendere il proprio operato una “variabile indipendente” che agisca come motore propulsivo di cambiamento sulla “variabile dipendente” della realtà sociale.
Per questi motivi, a maggior ragione, accostare il concetto di “competenza” ed “esperienza” all’uccisione di un altro essere umano appare semanticamente e moralmente inconcepibile. Ed è proprio questo il dato agghiacciante che chi rimane connesso all’Umano può rilevare nella pronuncia della Corte d’Assise di Venezia: questa sentenza non è figlia di incompetenza tecnica o “cialtronaggine” linguistica, ma di una profonda interiorizzazione, chiaramente indicata dalla scelta dei termini, delle dinamiche violente che caratterizzano la nostra società, in cui l’uccisione di un essere umano per mano di un altro essere umano appare normalizzata, tanto da essere soggetta ad una valutazione di perizia. Uno dei frutti marci di una cultura in cui la morte di altri esseri umani può diventare potenzialmente una professione, o addirittura una carriera. L’uso dell’aggettivo “efficace” rispetto all’inflizione di colpi nutre in sé l’intrinseca legittimazione della possibile finalità omicida di un atto, evento che rappresenta solo il culmine di quella violenza interna che ogni essere umano dovrebbe superare.
Per quanto virgolettato, colpisce come uno schiaffo la scelta dell’uso dell’aggettivo “pulito” per definire un’uccisione, come anche la scelta dei termini “funzionale” ed “iter” nel riferimento alla dinamica del femminicidio, come se questo fosse un procedimento strutturato e funzionante secondo regole di efficienza.
Per chi si adopera nel campo dell’umanizzazione, questo sguardo non stupisce. Ce lo ricorda tutti i giorni il riarmo globale a favore di un taglio delle spese di sanità e istruzione. Ce lo gridano le disuguaglianze e la sofferenza che attraversano il pianeta da polo a polo, ce lo indica la massa di invisibili dimenticati su scala mondiale perché estranei ad un gioco di interessi e sopraffazione che possa regalare loro una qualche utilità nella macchina dei potenti. Ce lo dice una sentenza davanti alla quale, connettendoci profondamente alla Forza interna che ci guida in una direzione luminosa e di senso, sentiamo nella carne ogni coltellata inflitta a Giulia, carica della cecità della violenza, pregna dell’assurdità e della contraddizione, totalizzata in quella banalità del male che ci fa credere che un’alternativa non sia possibile. Che un sistema di credenze in cui uomini e donne abbiano pari diritti, in cui la vita di un nero abbia lo stesso valore di quella di un bianco, nel quale la guerra venga abolita con ogni mezzo necessario, sia non solo legittimo ma imprescindibile.
Quella lama affonda settantacinque volte nella nostra incredulità, nel nostro dolore, nella nostra impotenza, ma anche nella nostra speranza. Che ogni Giulia del mondo sia salvata, un giorno, da una rivoluzione umana globale, da un’elevazione di coscienza, più forte di ogni sistema di diritto, che produca lo sgretolamento alla radice del bisogno di sopraffarsi per legittimarsi, animando invece l’ineluttabilità dell’abbattimento di quelle barriere che ci illudono di essere qualcosa di diverso dall’altro da noi. Per ritrovarci infine pieni, elevati, vivi e teneramente umani.