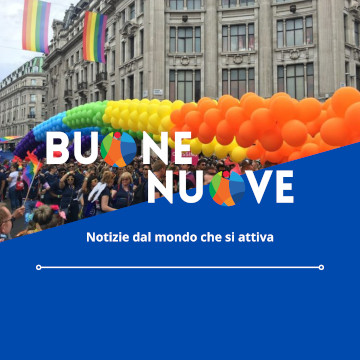Si stima che nell’Unione Europea gli over 65 raggiungeranno nel 2050 i 129,8 milioni. L’Italia è il paese europeo che invecchia più di tutti e più velocemente e decresce come popolazione, l’Istat ci dice che nel 2080 saremo poco più di 46 milioni di abitanti per la maggior parte anziani con un Sud sempre più abbandonato e “vecchio”. Ma non finisce qui. Tra 20 anni quattro famiglie su 10 saranno costituite da persone sole. Entro il 2043 le persone sole con più di 75 anni saranno 4,1 milioni, di questi 3 milioni saranno donne. Nel 2040 si raggiungerà un vero e proprio picco con quasi 18 milioni e mezzo di over 65. Previsioni demografiche da far tremare i polsi. A preoccupare non è solo l’invecchiamento della popolazione ma anche la ridotta natalità, un abbinamento che determinerebbe una progressiva riduzione della popolazione, cosa che sta già avvenendo. Sono alcuni dei dati dell’interessante ricerca AUSER a cura di Claudio Falasca contro i luoghi comuni su anziani e invecchiamento della popolazione dal titolo: “Vivere la longevità. L’invecchiamento attivo nella transizione demografica per un welfare generativo”.
L’Italia non solo è il Paese più anziano d’Europa ma è anche quello che invecchia più velocemente: l’età media al primo gennaio 2024 era di 48,7 anni (contro quella europea di 44,7) ed è aumentata di 4 anni rispetto al 2014 (contro un aumento a livello europeo di 2,2 anni). Secondo la ricerca di Auser la transizione demografica, se non attentamente governata con lungimiranti politiche di invecchiamento attivo, determinerà una progressiva riduzione della popolazione in generale, cosa che sta già avvenendo, e di quella attiva in particolare, con una conseguente contrazione del mercato del lavoro, un minore afflusso di risorse al sistema previdenziale, una maggiore spesa per l’assistenza socio sanitaria. La popolazione decresce e il fenomeno sarà differente nelle diverse realtà del Paese. L’Istat ci dice che nell’arco di alcuni decenni gli italiani dai 59,0 milioni al 2023, decresceranno, secondo lo scenario mediano, a 58,6 milioni nel 2030, a 57,0 milioni nel 2040, a 54,8 nel 2050, a 46,1 milioni nel 2080. Ma la decrescita non sarà ovunque uguale e il Sud sarà sempre più vecchio: secondo le previsioni ISTAT nel 2080 nelle regioni del Nord risiederà il 53,8% della popolazione nazionale, a fronte del 41,8% di oggi; il mezzogiorno invece arriverebbe ad accoglierne il 26% a fronte dell’attuale 33,7%. Mentre però decresce la popolazione in generale, aumentano le persone con più di 65 anni. Nel 2040 si raggiungerà un vero e proprio picco con quasi 18milioni e mezzo di over 65. La classe compresa tra i 65 e i 74 anni dall’48,7% nel 2023, si conferma al 48,2 nel 2040 per ridursi poi al 40,3% nel 2080. Il comportamento della classe compresa tra i 75-84 passa dal 35,4% nel 2023, al 35,3% nel 2040% per attestarsi al 36% nel 2080. La classe di età degli over 85 e quindi dei “grandi vecchi”, mostra una maggiore vivacità passando dal 15,8% nel 2023, al 23,7% nel 2080, quando i grandi vecchi saranno circa 4 milioni. In sostanza quando più di un terzo della popolazione italiana avrà più di 65, un terzo di questi saranno “grandi vecchi” con più di 85 anni. Nel mentre diminuiscono i giovani: dagli attuali 16.173.221 residenti compresi nella fascia di età 0-30 anni, corrispondenti al 27,3% del totale della popolazione, si passerà a 13.843.065 nel 2040 (24,2%) e, successivamente a 11.145.092 nel 2080 (24,1%). In valore assoluto la perdita sarà di 1.978.970 al 2040 e di 5.028.129 nel 2080: il 31,1% in meno rispetto ad oggi. Per quanto riguarda invece il quadro migratorio, a una prima fase molto intensa, fino al 2040, cui corrisponde una media di flussi netti superiore alle 200mila unità annue, segue una fase di stabilizzazione che si protrae fino al 2080 a una media annuale di 165.000 unità. E tra 20 anni, infine, 4 famiglie su 10 costituite da persone sole, un anziano o una coppia di anziani soli.
Di fronte a questo scenario l’AUSER sottolinea che le famiglie rischiano di essere sempre meno in grado di garantire la cura diretta dei familiari anziani e “la conseguenza sarà che entrerà in crisi l’attuale pilastro della assistenza domiciliare nella cura a lungo termine. Un rischio che indiscutibilmente induce forte preoccupazione per gli effetti sulle condizioni di vita delle persone non autosufficienti e sui costi per le famiglie, se non interverranno profondi cambiamenti in seno al nostro sistema di welfare. In altre parole si dovrebbe lavorare alla costruzione di un sistema di domiciliarità e residenzialità fondato su un welfare territoriale esteso territorialmente, capillare nelle relazioni con la domanda di assistenza, efficiente ed efficace nei servizi. Purtroppo tutto questo non è dato considerando che la legge di riforma 33/2023 che prevede la realizzazione di questo nuovo modello, nei fatti è del tutto inattuata in quanto priva di finanziamenti adeguati. Le stesse misure previste dal PNRR allo stato non hanno modificato la situazione”.
Generalmente si tende a guardare all’invecchiamento quasi sempre dal lato dei costi (gli anziani con problemi di salute), assumendo implicitamente che il fenomeno si configuri come un peso per la collettività (spesa sanitaria, sociosanitaria, pensionistica, prevenzione, ecc.). Negli ultimi anni si comincia però a prendere in considerazione anche le opportunità che offre l’invecchiamento in quanto titolari di una relativa stabilità economica e quindi target appetibile per imprese di vario tipo (la silver economy per beni e servizi a misura di anziani). A ben vedere due modi speculari di guardare alla transizione: gli anziani come consumatori, che si tratti di beni e servizi sanitari o di beni di consumo di altro tipo cambia poco. Manca del tutto una analisi di quello che gli anziani possono e vogliono dare alla comunità. “Eppure, sottolinea nel rapporto, milioni di essi si impegnano quotidianamente all’interno delle loro famiglie in attività di supporto che spaziano dalla cura di familiari non autosufficienti, all’assistenza dei nipoti, dal sostegno al bilancio familiare, nella gestione della abitazione: un insieme di “servizi” che in termini monetari assomma a svariati miliardi di euro. Numerose le ragioni per cui lo fanno: sicuramente per ragioni affettive, ma anche per sentirsi utili e attivi, non da ultimo perché non ci sarebbero alternative ai “servizi” che garantiscono e quelli disponibili sul mercato sarebbero troppo onerosi per i bilanci familiari. Negli ultimi decenni, via via che si allungava l’aspettativa di vita e cresceva il tempo libero dal lavoro, gli anziani hanno progressivamente rivolto il loro interesse anche verso la comunità in attività di utilità sociale. Da questo punto di vista l’impegno nei doveri verso la famiglia si è configurato come una sorta di palestra alla partecipazione sociale”.
Qui la ricerca: https://www.auser.it/wp-content/uploads/2025/03/Vivere-la-longevita_web.pdf.