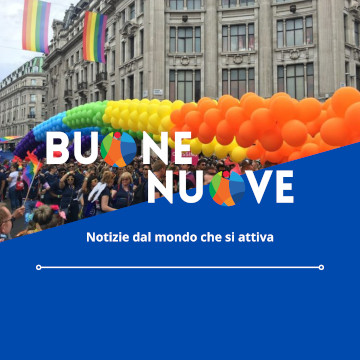Per un po’ tutti abbiamo voluto o finto di crederci: che da una parte ci fosse solo l’1% (di fatto, lo 0,0001 %, i padroni della Terra) e dall’altra tutti gli altri, noi. Non era, non è, così. Intorno a quel pugno di potenti c’è una solidissima struttura: una gerarchia di uomini e donne, ciascuno e ciascuna al “suo” posto, con dei compiti ben definiti, che lungo i rami – o meglio le radici – del potere arriva a coinvolgere cerchie sempre più ampie di “complici”: chi per interesse o per vantaggi, chi per abitudine, chi per servilismo, chi per non conoscere o vedere alternative.
Lungo quella serie di cerchie concentriche si può arrivare molto in là. In mezzo, da qualche parte, a un qualche livello, ci siamo noi; in parte consapevoli, in parte no, del nostro ruolo e delle nostre responsabilità. Puntare sulla contrapposizione tra due blocchi, gli emarginati e gli inclusi, “i sommersi e i salvati”, non sposta i termini della questione. A volte allarga un po’ l’area degli esclusi a spese del blocco del potere, a volte la restringe e dilata quella di chi si sente, o si vuole, incluso. Il problema è tagliare quella piramide sociale, cercare di destrutturarla a ognuno dei suoi livelli intermedi, a partire dalle ragioni specifiche di disagio nei confronti della sua posizione che ciascuno e ciascuna avverte già oggi, o potrebbe avvertire domani. E’ quella “lunga marcia attraverso le istituzioni” di sessantottesca memoria troppo a lungo dimenticata. A ciascuno di quei livelli, in ogni articolazione di quella struttura, ci sono oppressi e oppressori, contraddizioni che possono esplodere. La più esplosiva – oggi lo sappiamo, sessant’anni fa forse no – è quella di genere, tra donne e uomini, il patriarcato: lì si trova il bandolo per affrontare, e forse dipanare, tutte le altre. Basta non abusarne.
Invece è stata evocata più volte un’analogia tra l’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina (non tra Israele e gli abitanti della Striscia di Gaza; caso mai solo il viceversa) e uno stupro o un femminicidio. Sostenere che è stata l’Ucraina, o chi per essa, a provocare e spingere la Russia a muovere quella guerra feroce sarebbe come dire che la donna molestata, stuprata o ammazzata “se l’è andata a cercare”. Quell’analogia non regge. Intanto c’è di mezzo quel “chi per essa: forse l’Ucraina è solo la vittima di un gioco più grande di lei. Ma a invalidare quell’analogia c’è il fatto che ogni donna è un’unità indissolubile di corpo e di anima, di aspetto esteriore – il modo di vestire, di truccarsi, di atteggiarsi – e di vissuto: quanto ciascuna si porta dietro del tanto o poco di cui ha fatto esperienza nella sua vita.
Un Paese, una nazione, uno Stato, invece, sono un’altra cosa: non un’unità indissolubile ma un coacervo di “cerchie”, di posizioni, di interessi e punti di vista diversi. Dimenticare queste diversità, anche nel momento in cui forse appaiono meno chiare, ma sapendo che sono comunque destinate a palesarsi, è perdere di vista le ragioni che ci hanno guidato negli anni, nel corso delle più diverse vicende di cui siamo stati attori o spettatori: la distinzione tra oppressi e oppressori, sfruttati e sfruttatori, dominati e dominanti, tra chi sta alla base della piramide sociale e chi al suo vertice. Una distinzione che gli sviluppi della guerra in Ucraina stanno portando alla luce ogni giorno di più: sia quella tra le vittime dirette della guerra, civili o soldati, da quelli arruolatisi volontariamente a chi cerca di sottrarsi alla guerra con la fuga, la renitenza o la diserzione, da un lato e dall’altro, chi, al vertice di una delle tante piramidi sociali coinvolte, in Ucraina e “all’estero”, non ha fatto niente per evitare quella guerra e continua ad adoperarsi per protrarla “fino alla vittoria”. Ignorando, per forza di cose, le sofferenze di chi non ha niente da guadagnarci, né ora né domani. Poi c’è anche il rischio di guardare solo a questo lato del fronte, quello che i media occidentali ci fanno vedere, ignorando quello che succede “dall’altra parte”. Che senso ha battersi per la conquista o la riconquista di territori che la guerra sta rendendo inabitabili per decenni a venire?
Quella riluttanza a distinguere tra oppressi e oppressori ha finito per alimentare, oltre allo strazio a cui sono state condannate, oggi come per tutto il loro futuro, le vittime di questa come di tutte le altre guerre, e certo al di là delle intenzioni dei molti che hanno contribuito a suscitarla, l’evocazione di uno spirito bellicoso, da “maggio radioso”, che invoca “la vittoria” come unica alternativa alla “resa”. Si dimentica che la vittoria, se mai ci sarà (e di chi?), sarà di pochi, mentre all’opposto, questa volta sì per il 99%, non ci sarà che sconfitta.
Il risultato è che si parla solo più di guerra come orizzonte delle nostre vite, tanto che persino nelle scuole, dove ogni discussione sul genere (“gender”) viene bandita come farina del demonio – ma è anche stato espulso da tempo, dal modo in cui vengono trattate le diverse “materie”, siano esse le letterature, la storia, la geografia, la chimica, la fisica o la matematica, ogni riferimento all’amore, non solo per le persone, ma anche per gli animali, le piante, il vivente, la mente, la Terra – viene invece introdotto per decreto l’insegnamento della guerra e della preparazione alla guerra: un’ennesima materia curricolare da aggiungere all’educazione civica, a quella ambientale, a quella sessuale (ma detta “del cuore”), all’alternanza scuola-lavoro…
Ma per tornare allo stupro e al femminicidio, ve li immaginate gli insegnanti di oggi, frustrati dai moduli, dai tablet, dai “programmi”, dalle valutazioni, dalle aggressioni di studenti e genitori, dal pubblico disprezzo, dallo stipendio ridicolo, dalla competizione quotidiana con i social per conquistare l’attenzione degli allievi, insegnare loro educazione sessuale, cioè “al cuore”, come misura di prevenzione delle molestie, dei femminicidi, dello stupro?
E’ evidente che bisogna cominciare da un’altra parte. Aprire le scuole alla vita del Paese o del quartiere, a quella delle piante e degli animali, al cielo e agli astri, far vedere la Terra vista dal cielo: Gaia, un unico grande organismo tenuto in vita dall’aria, dalle acque, dal suolo e dagli ecosistemi che la ricoprono e di cui anche noi, ciascuno di noi, è parte. Ce lo siamo dimenticati.