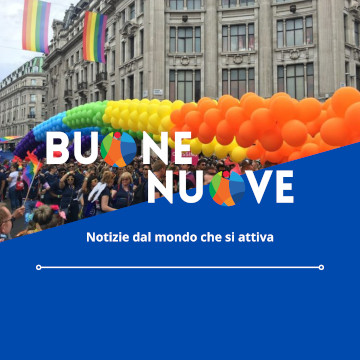Nella situazione di tensione che si respira nel Paese, la Bolivia, o, più precisamente, lo Stato Plurinazionale di Bolivia, ha registrato un nuovo, drammatico momento di crisi lo scorso ottobre, quando l’ex presidente, protagonista storico della trasformazione in senso progressista del Paese, Evo Morales, è risultato vittima di un attentato, dal quale è per fortuna risultato illeso. Domenica 27 ottobre, infatti, l’auto su cui stava viaggiando, tra Villa Tunari e Shinahota, nella regione centrale di Cochabamba, è stata attaccata da quattro incappucciati, che hanno sparato contro la vettura, ferendo l’autista, ma lasciando, fortunatamente, illeso l’ex presidente.
Il governo boliviano, attualmente guidato dal presidente socialista Luis Arce, ha dichiarato l’apertura di un’indagine per fare chiarezza su quanto accaduto. Non v’è dubbio che questo evento si inserisca nel clima di tensione che il Paese attraversa: le elezioni generali in Bolivia sono state indette per il prossimo 17 agosto, saranno elezioni decisive per il partito al governo, il MAS, il Movimento al Socialismo, da cui provengono, peraltro, sia l’ex presidente, Morales, sia l’attuale presidente, Arce, e saranno più ancora decisive per garantire la continuità della rivoluzione plurinazionale e le sue conquiste politiche e sociali, una rivoluzione popolare che ha visto l’affermazione di conquiste di dignità, libertà e diritti che mai prima il Paese aveva conosciuto.
L’orientamento della rivoluzione boliviana, nel contesto più generale delle rivoluzioni di orientamento socialista, umanista e bolivariano che hanno attraversato l’America Latina, è, infatti, prima con Morales e ora con Arce, al tempo stesso socialista e indigenista e ha consentito un inedito e vastissimo avanzamento sociale nel Paese: ancora negli anni Ottanta il tasso di analfabetismo era superiore al 20 per cento e la mortalità infantile superiore a 66 per mille nati; l’economia era dominata dall’agricoltura di sussistenza e le straordinarie risorse minerarie (la Bolivia possiede i più grandi giacimenti di litio al mondo, nonché oro, argento, stagno, petrolio e gas naturale) appannaggio delle grandi multinazionali straniere, a beneficio della borghesia compradora locale, e completamente sottratte a benefici diffusi e bisogni sociali.
Con la rivoluzione plurinazionale, si è avviato il programma di nazionalizzazione delle risorse della Bolivia; se prima le multinazionali straniere del gas pagavano al governo il 18%, dal 2006 le stesse aziende possono trattenere solo il 18%, mentre lo Stato, a beneficio del sistema sociale e delle politiche sociali, riceve l’82% dei profitti. Con la rivoluzione, la povertà assoluta è scesa dal 38% al 17%, lo stato sociale è stato per la prima volta organizzato e finanziato, l’analfabetismo è scomparso e la mortalità infantile si è dimezzata. Coronamento del processo, la trasformazione costituzionale: la rivoluzione, come sancito dalla Costituzione, trasforma la Bolivia in uno “Stato sociale di diritto comunitario plurinazionale, libero, indipendente, sovrano, democratico, interculturale, decentrato e dotato di autonomie. Si fonda sulla pluralità e sul pluralismo politico, economico, giuridico, culturale e linguistico, nel quadro del processo di integrazione del Paese”.
Il deterioramento del panorama internazionale e la crisi economica si sono tuttavia fatti sentire pesantemente sulla Bolivia negli ultimi anni, soprattutto a causa della crisi energetica, con la riduzione della produzione di gas naturale, che ha portato a difficoltà nell’approvvigionamento di carburante e a una pesante inflazione. In questo quadro la crisi è, al tempo stesso, economica e politica. La tensione in corso riguarda anche, direttamente, le due principali personalità del MAS: da una parte Morales ha manifestato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali; dall’altra, una sentenza della Corte Costituzionale della Bolivia, emessa il 29 dicembre 2023, conferma il divieto di qualsiasi ipotesi di “rielezione presidenziale a tempo indeterminato”, escludendo così formalmente Morales dalla corsa per le prossime presidenziali.
La sentenza è anche un’interpretazione dell’articolo della Costituzione su cui pesavano dubbi interpretativi, laddove stabilisce (art. 168) che “Il mandato del presidente o del vice presidente è di cinque anni e il presidente e il vice presidente possono essere rieletti una sola volta per un mandato continuativo”. Il dubbio interpretativo riguardava dunque l’impossibilità di candidarsi per un mandato ulteriore dopo avere già completato due mandati (in generale) o, specificamente, due mandati consecutivi, proprio come nel caso di Morales, presidente della Bolivia dal 2006 al 2019 e primo presidente indigeno nella storia del Paese. Oggi, l’interesse dell’imperialismo, rinnovato anche dalla nuova strategia di Trump, particolarmente aggressiva nei confronti dell’America Latina e, a maggior ragione, delle esperienze di trasformazione e di protagonismo sociale, è di far ripiombare la Bolivia nella più totale subordinazione agli Usa, un ritorno al passato, al “giardino di casa”.
È della fine del febbraio scorso la notizia che Morales ha presentato formale rinuncia al MAS, il Movimento al Socialismo fondato nel 1987 e che continua a governare, con Luis Arce, il Paese. Grande è il patrimonio, in termini di memoria sociale e politica, che il MAS porta con sé: esso nacque come forma politica autonoma della Falange Socialista Boliviana, uno storico movimento di ispirazione nazionalista, e confluirono in esso ispirazioni e tendenze che facevano riferimento al marxismo, nonché, nel campo del movimento rivoluzionario, al maoismo e al guevarismo, e poi al patriottismo e al nazionalismo progressista, nonché ancora a quella particolare forma politica dell’indigenismo che è conosciuta come “katarismo”, basata nella tradizione e nella cultura del popolo aymara e centrata nella lotta contro la “doppia oppressione” dei popoli indigeni della Bolivia: quella di classe, in chiave marxista, e quella nazionale, in chiave coloniale. Esso recupera, sin nel nome, il riferimento a Túpac Katari, protagonista di una delle più rilevanti ribellioni indigene (1781) contro il dominio coloniale spagnolo nella regione.
Il Movimento si riconosce, ieri come oggi, nei dieci punti-base del programma: uguaglianza tra tutti i popoli della Bolivia; lotta alla corruzione; nazionalizzazione delle risorse energetiche e dei mezzi fondamentali della produzione; industrializzazione del settore energetico; rinnovamento morale, etico, politico; avanzamento e progresso, economico e sociale, del Paese; riconoscimento della dignità e dell’eroismo dei popoli della Bolivia nei confronti dell’Europa durante la colonizzazione; integrazione del patrimonio culturale originario; lotta al capitalismo, al neoliberalismo e all’imperialismo; rispetto dei diritti umani per tutti e per tutte.
È dello scorso 31 marzo la notizia della formazione del nuovo partito guidato da Evo Morales, con la denominazione “Evo Pueblo”, attraverso cui raccogliere le cerchie dei sostenitori e intentare anche una denuncia contro l’attuale presidente Luis Arce, per portare la magistratura a indagare sulla sua famiglia e su suoi presunti “patrimoni”. Al tempo stesso, Morales ha annunciato l’intenzione di candidarsi comunque alle prossime elezioni con il partito “Frente para la Victoria” (FPV), un piccolo partito di orientamento indigenista e con una ideologia, per dirla in termini occidentali, di “populismo contadino”, fondato nel 2009 e dal piccolo seguito elettorale (1.5% alle elezioni del 2020). Da parte sua, Morales ha ribadito che il rapporto con l’FPV è un «accordo», non una «alleanza».
Anche rispetto a tutto questo, le elezioni del prossimo 17 agosto saranno un momento delicato, e decisivo.