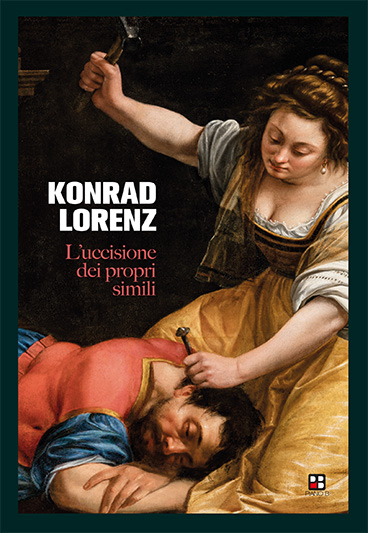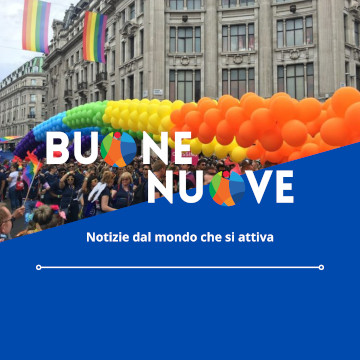L’anno scorso, nella loro interessante ricerca di testi inediti che affrontino la grandi problematiche del tempo presente le Edizioni Piano B hanno pubblicato sotto il titolo de L’uccisione dei propri simili estratti da un pubblicazione di Konrad Lorenz Der Wirkungsgefuge der Natur und das Shicksal des Menschen pubblicata a Berlino nel 1978 ma che forse riunisce testi più vicini alla Seconda Guerra Mondiale, dati alcuni riferimenti.
Il tentativo dell’Opera, probabilmente già nella sua versione originale sta nella comprensione del fenomeno della guerra e dell’uccisione dei propri simili.
Nella ricompilazione proposta Lorenz enuncia i numerosi casi di uccisione dei propri simili nel mondo animale; dalla solita e precisa enunciazione dei casi e delle fonti, sia dirette che indirette, l’inventore della etologia tira fuori tutto il suo sapere e lo fa nel suo stile tipico: preciso e divulgativo. In una estrema sintesi potremmo dire che i casi di uccisione dei propri simili sono frequenti in tutte le specie animali ma derivano, nella stragrande maggioranza di casi da comportamenti rituali, istintivi legati a aspetti cruciali della conservazione della specie così come la riproduzione. Cioè una correlazione chiara che l’autore stabilisce è che la soppressione di un proprio simile ha molto spesso relazione diretta con le possibilità di sopravvivenza della specie. Perché se due maschi combattono a morte per chi si accoppierà con la femmina è abbastanza probabile che il vincitore sarà colui che assicurerà una migliore genetica di sopravvivenza alla sua specie.
Ci sono eccezioni a questa tendenza, comportamenti come quello della Mantide che sfuggono a una logica genetica e sfociano in una bizzarria etologica che però resta nel campo degli istinti e dei comportamenti geneticamente trasmessi.
Cioè nulla di intenzionale sembra arrivare dal mondo animale.
A questo punto, quasi scusandosi di smettere i panni dell’etologo per indossarne altri, affronta la questione umana: perché gli umani uccidono i propri simili?
La domanda doveva essere impellente all’epoca ed anche noi eravamo lì aspettando che Konrad ci illuminasse con la sua scienza.
Come premessa Lorenz dedica molto tempo a rimarcare la differenza tra l’animale e l’uomo, citando i famosi studi di Köhler sull’intelligenza pratica degli scimpanzé: dice che tra l’animale e l’uomo c’è la stessa differenza tra l’organico e l’inorganico e qui fa un’affermazione a mio avviso incauta e che, soprattutto, non mi aspettavo dall’etologo dato che, leggendo il libro, speravo che mi illuminasse sulle caratteristiche squisitamente animali della specie umana.
Invece Lorenz continua con la linea della differenziazione citando vari studi e mettendo in mezzo il concetto di civiltà e quello di malattie della civiltà, dimenticano però, come purtroppo molti studiosi di quell’epoca, di dare una definizione chiara di Essere Umano. Vede nello sviluppo della tecnologia uno dei fattori scatenanti dell’aggressività umana ma finisce per non spiegarlo in modo esauriente e, se lo pensiamo in prospettiva e accelerazione storica lo sviluppo della tecnologia attuale dovrebbe aver accentuato il fenomeno in maniera esponenziale.
In sintesi un interessante saggio sull’aggressività animale e un nobile tentativo, a mio avviso fallito, di comprendere la follia omicida che attraversa gli esseri umani in particolare in alcuni momenti e in certe condizioni.
Restiamo col dubbio e la curiosità, anche prima di una più interessante definizione dell’Essere Umano, di quali possano essere gli elementi animali, genetici ed istintuali che potrebbero facilitare l’insediamento della violenza nel comportamento umano, insediamento che alcuni studi recenti di neuroscienza hanno definito acquisito e non presente nel patrimonio genetico umano. Il dibattito e la ricerca sono aperti.