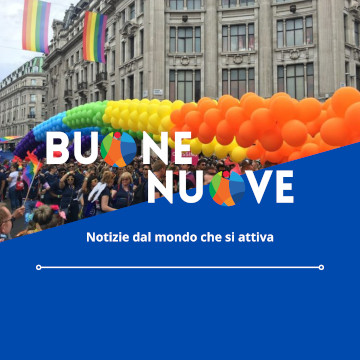Il sito d’inchiesta La Tabla.org ha pubblicato un’analisi politica in merito alla proposta dell’opposizione venezuelana di destra per la riforma energetica. Una riforma neoliberista e del tutto impraticabile. Di seguito l’articolo.
La riforma energetica presentata questa settimana dall’opposizione venezuelana alla conferenza CERAWeek, che promette di attrarre investimenti stranieri per salvare l’industria petrolifera, si scontra con una realtà innegabile: l’impossibilità politica della sua attuazione.
Il PSUV del presidente Nicolás Maduro e altri partiti alleati mantengono l’egemonia su tutti i poteri pubblici, tra cui l’Assemblea nazionale, il sistema giudiziario e il PDVSA, mentre l’opposizione non ha l’autorità esecutiva per guidare il cambiamento. Inoltre, qualsiasi emendamento costituzionale che comportasse la privatizzazione dei beni statali richiederebbe un referendum popolare, uno scenario che, lungi dall’indebolire il governo, potrebbe legittimarlo.
Il piano, che propone di ridurre la quota statale delle entrate petrolifere e di aprire le gare d’appalto private, rilancia lo storico dilemma tra nazionalismo e apertura economica. I critici sottolineano che, se l’accordo andasse avanti, il Venezuela sacrificherebbe la propria sovranità e trasparenza a vantaggio delle multinazionali, senza alcuna garanzia di una ripresa sostenibile. A ciò si aggiunge un rischio economico importante: un aumento della produzione a 3 milioni di barili al giorno (bpd) potrebbe saturare il mercato e far crollare i prezzi del greggio sotto i 60 dollari, incidendo ulteriormente sulle casse del Paese, già esauste.
I. Fattibilità politica: un progetto senza base istituzionale
1. Maduro (il suo partito e i suoi alleati) hanno l’egemonia:
– Il settore dell’opposizione dietro la proposta (González e Machado) non ha rappresentanza nell’Assemblea nazionale o negli organi di regolamentazione.
– “È una lettera di buone intenzioni, ma senza accesso alle istituzioni è inutile”, conclude qualsiasi analisi.
2. La riforma costituzionale: un boomerang per l’opposizione:
– La Costituzione del 1999 (art. 12 e 302) stabilisce che le risorse petrolifere sono “proprietà inalienabile della Repubblica”. Il trasferimento di beni a privati richiederebbe un referendum, che diventerebbe un plebiscito a favore del governo.
– “Maduro userebbe un referendum per mostrare il suo sostegno e affossare la proposta dell’opposizione”, spiega una fonte del CNE che ha chiesto l’anonimato.
3. Sanzioni e isolamento:
– Sebbene l’opposizione cerchi il sostegno degli Stati Uniti, le sanzioni restano in vigore. A marzo, Washington ha revocato la licenza alla Chevron. Senza un disgelo politico, aziende come Shell e TotalEnergy eviteranno di investire.
II. Apertura vs. nazionalismo: chi perde?
Il nocciolo della proposta – cedere i giacimenti petroliferi a compagnie straniere tramite gara privata – si scontra con tre critiche centrali:
1. Riduzione delle entrate statali:
– Attualmente, la PDVSA trattiene fino all’80% dei profitti in joint venture. La riforma consentirebbe alle aziende di aumentare la loro partecipazione, riducendo la quota statale.
– “Si tratta di un ritorno al modello di concessione del XX secolo, in cui le multinazionali facevano la parte del leone”, un’affermazione verificabile nei libri di storia.
2. Opacità nelle gare d’appalto:
– La proposta stabilisce che l’assegnazione dei campi avverrebbe tramite gare private, non tramite meccanismi pubblici. Il meccanismo stesso è visto come un fattore di opacità. Se a tutto questo si aggiunge la storia di corruzione della PDVSA, il modello diventerebbe una nuova fonte di sfiducia.
3. Rischio di dipendenza neocoloniale:
– Il piano non include clausole per il trasferimento di tecnologia o la formazione di manodopera locale. “Il Venezuela sarebbe un semplice esportatore di petrolio greggio, senza alcun valore aggiunto”, critica un rapporto di un istituto di ricerca.
III. Obiettivo 3 milioni di barili al giorno: una “iniezione di fiducia” economica?
La proposta promette di aumentare la produzione da 920.000 bpd (2023) a livelli mai visti dal 2008. Tuttavia, gli esperti avvertono:
1. Saturazione del mercato:
– Il Venezuela contribuirebbe al 3% della produzione globale (100 milioni di bpd). Un aumento improvviso farebbe scendere i prezzi, soprattutto se la domanda non aumentasse. Nel 2023, il prezzo del petrolio greggio venezuelano era di 65 dollari; Secondo Goldman Sachs, un surplus potrebbe farla precipitare a 50-55 dollari.
– «Guadagneremmo volume, ma perderemmo valore. “È un’equazione perdente”, riassume un economista dell’UCV.
2. Infrastruttura crollata:
– PDVSA ha bisogno di 200 miliardi di dollari per modernizzare pozzi, raffinerie e oleodotti. “Anche con investimenti stranieri, la capacità operativa non verrebbe recuperata in meno di un decennio”, afferma un ex dirigente aziendale.
3. Mancanza di diversificazione:
– Il piano non affronta la dipendenza dal petrolio (96% delle esportazioni). “Se i prezzi scendono, non ci sarà un piano B per l’economia”, avvertono gli osservatori.
IV. Reazioni: Scetticismo interno ed esterno
– Governo Maduro: ha definito la proposta una “resa del Paese”. Tuttavia, Maduro ha affermato di essere “aperto agli investimenti” alle sue condizioni, il che riflette una duplice strategia: logorare l’opposizione e al contempo negoziare con alleati come Cina e Russia.
– Stati Uniti ed Europa: sostengono il dialogo, ma subordinano l’allentamento delle sanzioni ai progressi politici ed elettorali. “Non ci saranno assegni in bianco per una proposta senza consenso interno”, ha affermato un funzionario del Dipartimento di Stato.
– Compagnie petrolifere: preferiscono aspettare. “Senza certezza giuridica, è troppo rischioso”, ha confessato un dirigente della BP a Houston.
Conclusione: una proposta senza un percorso chiaro
La riforma energetica dell’opposizione, sebbene tecnicamente ambiziosa, è nata morta politicamente. Maduro mantiene il controllo delle istituzioni, le sanzioni limitano i capitali stranieri e lo spettro di un calo dei prezzi del petrolio espone la sua fragilità economica. Nel frattempo, il dilemma tra apertura e nazionalismo resta irrisolto: dovremmo accettare il costo della cessione della sovranità per investimenti che potrebbero non arrivare?