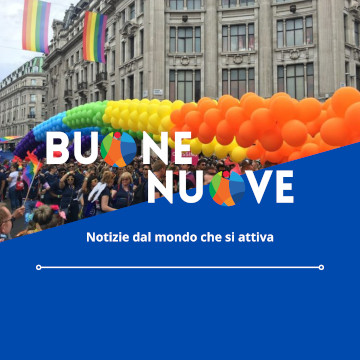Dai fenomeni vulcanici e tellurici dei Campi Flegrei, alle esondazioni in Emilia e Toscana i disastri ambientali stanno interessando gran parte del territorio italiano.
Lo sviluppo incontrollato dell’attività umana, la presunzione che la tecnologia possa governare la natura, la spasmodica ricerca del profitto capitalista e lo sfruttamento senza limiti delle risorse naturali possono essere considerate le cause principali di centinaia di disastri ambientali negli ultimi due secoli, disastri che senza l’intervento devastante dell’uomo si verificherebbero molto più di rado.
La distruzione degli habitat naturali, non ha solo un impatto sulle singole specie, ma anche sulla salute dell’ecosistema globale. La distruzione degli habitat è principalmente causata dall’uomo. Il disboscamento dei terreni per far spazio all’agricoltura intensiva, il pascolo per la produzione massiccia di carne e latte, l’estrazione mineraria, le trivellazioni, l’imbrigliamento dei corsi d’acqua e l’urbanizzazione hanno un impatto sull’80% delle specie globali.
Già nel 2020 il Global Risks Report metteva in evidenza che “i rischi globali in cima alla lista in termini di probabilità sono tutti riconducibili all’ambiente”. Fra questi troviamo gli eventi meteorologici estremi; il fallimento delle politiche di adattamento al cambiamento climatico; gravi catastrofi naturali (come gli tsunami e grandi frane); gravi perdite di biodiversità e collasso dell’ecosistema; danni e disastri ambientali causati dall’uomo.
L’attività umana, viziata dal modernismo capitalista, influenza pesantemente l’ambiente naturale creando le condizioni per il verificarsi dei disastri ambientali.
L’EM-DAT (il principale database internazionale degli eventi catastrofici) negli ultimi vent’anni ha registrato più di 6767 catastrofi meteorologiche che hanno causato centinaia di migliaia di vittime e milioni di persone senza tetto e bisognose di assistenza d’emergenza.
La perdita del rapporto proficuo fra attività umana e territorio, il distacco crescente fra sviluppo tecnologico e natura hanno prodotto la devastazione dell’ambiente con la vana presunzione del modernismo capitalista di potere governare la natura con la tecnica e la scienza.
Oggi assistiamo impotenti a fenomeni naturali che contrastano con l’antropizzazione del territorio.
Esempio tangibile è ciò che osserviamo in tutta l’area dei Campi Flegrei dove negli ultimi 150 anni abbiamo assistito ad un insensato sviluppo urbanistico che ha visto la costruzione di interi quartieri residenziali, di ospedali, scuole, caserme all’interno di crateri vulcanici in una zona che dall’origine di tempi è stata sempre soggetta a fenomeni vulcanici eruttivi, bradisismi e terremoti.
A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, in tutto il bacino dei Campi Flegrei (che comprende 12 comuni fra i quali Pozzuoli, Bagnoli, Fuori Grotta) c’è stato un incremento esponenziale della popolazione che ha raggiunto la cifra attuale di un milione e mezzo di abitanti. Interi complessi abitativi sono stati costruiti in zone che dovrebbero essere interdette all’attività umana. Persino sul ciglio del cratere della solfatara spiccano numerosi edifici densamente abitati.
Il rischio legato ai fenomeni vulcanici nei Campi Flegrei non può essere sottovalutato, soprattutto considerata la densità abitativa della zona, dove anche una piccola eruzione potrebbe creare danni ingenti a cose e persone. Una probabile eruzione non si sa dove e quando esattamente potrà avvenire, ma potrebbe colpire un punto qualunque nell’intera area della caldera, che è decisamente estesa con un diametro di 12-13 km.
L’attività sismica dei Campi Flegrei ha prodotto negli ultimi 10 mesi due forti scosse di magnitudo 4.4° sulla scala Richter, una il 13 marzo 2025 e una il 20 maggio 2024. Il commissario alla Protezione Civile ha affermato che una scossa del 5° della scala Richter provocherebbe il crollo della gran parte degli edifici con conseguenze catastrofiche. I fenomeni tellurici sono un “effetto collaterale” dell’attività vulcanica di quest’area. L’intero fenomeno del bradisismo che produce i terremoti nei Campi Flegrei è un fenomeno di origine magmatica che fa alzare e abbassare il suolo, dando origine a frequenti sciami sismici nei periodi di sollevamento (il fenomeno è costantemente in corso dal 2005).
Affrontare il problema è una questione ovviamente scientifica, ma che coinvolge direttamente il sociale. La popolazione dell’area Flegrea che da decenni convive con il vulcano ha bisogno di reali investimenti sulla prevenzione, sulle vie di evacuazione e su alternative abitative concrete lontano dalle zone sismiche e vulcaniche. Amministratori, Governo, Protezione Civile rimangono ciechi di fronte all’evidenza dei fatti e sordi davanti alle prove messe sul tavolo dalla comunità scientifica. I piani governativi che ipotizzano la costruzione di una new town nella zona dell’ex Italsider di Bagnoli, in piena zona vulcanica, sono pura follia. Non si affronta seriamente il problema, non si pensa ad una soluzione reale per la gente che vive costantemente con il pericolo sotto i piedi, ma si segue la strada della colata di cemento per ingrassare gli speculatori del mattone.
In Italia centrale e del nord (ma spesse volte anche in Italia meridionale e nella Sicilia orientale), in particolare in Toscana e in Emilia, assistiamo a frequenti fenomeni meteorologici che provocano inondazioni e disastri alle abitazioni, alle vie di comunicazione e alla attività economiche. Le frequenti piogge trovano un ambiente modificato che non permette il normale assorbimento dell’acqua e provoca il conseguente ingrossamento di fiumi e canali con fenomeni di esondazione frequenti.
Negli ultimi due secoli in tutta Italia, sotto la spinta del modernismo capitalista, c’è stata un’intensa antropizzazione dei terreni. I fiumi sono stati imbrigliati, gli argini notevolmente elevati. Sono state sottratte agli alvei dei fiumi notevoli porzioni di territorio dove sono state impiantate fattorie, frutteti, attività commerciali, fabbriche, zone residenziali.
I corsi d’acqua, oltre ad essere stati imbrigliati, spesse volte sono stati anche cementati o tombati.
L’acqua che nella normalità naturale viene assorbita lentamente dal suolo è stata canalizzata in corsi blindati che fungono da autostrade idriche che la trasportano direttamente e velocemente verso il mare.
É noto che il grande invaso per le acque è il sottosuolo. Favorire l’infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo è il metodo migliore per conservare l’acqua e preservarsi dalle inondazioni. Ma per fare questo occorre che il territorio sia poroso, come quello delle aree forestali poco disturbate, e che l’acqua scorra lentamente. Il principio fondamentale è dividere, rallentare, infiltrare. In un territorio poroso la percentuale maggiore delle precipitazioni segue il percorso sottopelle o profondo, con velocità decisamente basse. La chiave giusta per attenuare gli effetti distruttivi di precipitazioni elevate è aumentare in ogni modo il tempo che occorre alla generica goccia di pioggia caduta nel punto idraulicamente più lontano per raggiungere la sezione di chiusura del bacino idrografico (tempo di corrivazione).
Se vogliamo combattere alluvioni e siccità (due facce dello stesso problema) occorre, da subito, fermare la rarefazione dei boschi, ridurre i tagli, salvare la vegetazione ripariale, aumentare la porosità del territorio, attuare interventi di sistemazione estensiva a livello di bacino.
Il dott. Alessandro Bottacci (Professore a incarico di “Nature conservation” presso l’Università di Camerino) ha recentemente affermato che l’eliminazione della vegetazione ai lati dei corsi d’acqua, specialmente lungo le reti secondarie, velocizza la corrente idrica, diminuisce il tempo di corrivazione e trasforma la gran parte dell’energia dovuta al dislivello (energia potenziale) in energia cinetica. L’energia cinetica delle acque è pericolosa, erode ed è alla base delle inondazioni lampo, nei punti in cui non sia possibile mantenere una velocità di deflusso costante.
I politici, gli amministratori, i tecnici, gli imprenditori sono tutti inspiegabilmente concordi nel voler aumentare la velocità di deflusso superficiale (aumentando in questo modo l’energia cinetica) creando condizioni di grande pericolosità in caso di precipitazioni elevate e di siccità nei periodi di scarsi apporti idrici. Nonostante l’evidenza, continuano a scegliere quella strada, forse perché è più costosa e più facile per creare situazioni di emergenza, dove i fondi arrivano di corsa e senza tanti controlli. Occorre prendere coscienza dei ritmi della natura e pensare allo sviluppo del territorio in simbiosi con l’ambiente naturale imponendo il cambiamento della mentalità predatoria e affaristica di politici, amministratori e imprenditori affamati di profitti.