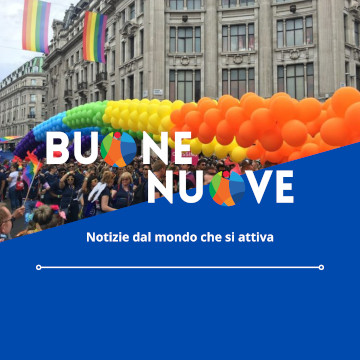La Groenlandia, controllata dalla Danimarca fin dalla sua espansione coloniale nel 18° secolo e ora rivendicata dagli Stati Uniti, è stata per secoli una pedina nelle mani di potenze straniere. Anche la Germania ha giocato più volte un ruolo.
Germania e Francia si sono impegnate a sostenere la Danimarca nella disputa sulla Groenlandia. Durante una breve visita del Primo Ministro danese Mette Frederiksen alla fine di gennaio, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno sottolineato il loro impegno per la sovranità territoriale di tutti gli Stati. Ciò ostacola l’incorporazione della Groenlandia negli Stati Uniti.
La Groenlandia, oggi parte autonoma del Regno di Danimarca, è stata esposta nella sua storia non solo alle rivendicazioni statunitensi, ma anche a quelle del triangolo Copenaghen-Washington-Berlino. L’invasione tedesca della Danimarca nell’aprile del 1940 portò alla fine della guerra alla creazione delle prime basi militari statunitensi sull’isola. In seguito, il saccheggio degli stock ittici nelle acque della Groenlandia da parte dei pescatori della Germania occidentale ha scatenato critiche massicce nei confronti dell’appartenenza dell’isola al predecessore dell’UE, la Comunità Europea (CE). Ciò ha portato alla fine a una netta maggioranza della popolazione groenlandese che ha votato a favore dell’uscita dalla CE nel 1982. Ancora oggi, gli esperti di politica estera considerano l’isola come “la porta dell’Europa verso l’Artico”, di cui beneficia anche la Repubblica Federale Tedesca.
La Danimarca come potenza coloniale
Oltre alle colonie dell’estremo nord, la Danimarca ne aveva conquistate altre nei Caraibi, dove la Compagnia danese delle Indie occidentali incorporò diverse isole nel corso del 17° e 18° secolo. Dopo il fallimento della Compagnia, nel 1754 lo Stato danese assunse il controllo diretto di gran parte dell’arcipelago delle Isole Vergini Danesi. La sua capitale St. Thomas, un porto franco, divenne nel corso del 19° secolo la porta d’ingresso per le spedizioni di Amburgo nei Caraibi.[1] Dopo la fondazione dell’Impero Tedesco, la Marina imperiale istituì la sua “Stazione dell’America orientale”, con navi da guerra tedesche che operavano nella regione principalmente da St. Thomas.[2]
La colonia danese servì quindi da trampolino di lancio per la politica tedesca delle cannoniere. Inoltre, il console statunitense nelle Isole Vergini danesi osservò che la Danimarca favoriva l’Impero Tedesco nelle questioni economiche del possedimento coloniale.[3] A causa delle attività della marina tedesca nei Caraibi, a Washington crebbe l’interesse per l’acquisto delle Isole Vergini danesi.[4] Alla fine di marzo del 1917, gli Stati Uniti le acquistarono effettivamente; una settimana dopo, il governo statunitense dichiarò guerra alla Germania.[5] Il trampolino di lancio tedesco nella regione era definitivamente perso.
La Terra di Erik il Rosso
Dopo la vittoria degli Alleati nella Prima Guerra Mondiale, il Trattato di Versailles e altri trattati conclusi a Parigi e dintorni regolarono le relazioni postbelliche in Europa. Allo stesso tempo, i governi di Francia, Gran Bretagna e Italia riconobbero la sovranità danese sulla Groenlandia, che Copenaghen rivendicava dal 1721 – dal momento in cui aveva conquistato anche le sue colonie caraibiche.[6]
Gli Stati Uniti avevano già riconosciuto la sovranità danese sulla Groenlandia nel 1917 con il Trattato delle Isole Vergini Danesi. Solo la Norvegia non era disposta a rinunciare alle proprie rivendicazioni sulla Groenlandia. Nel giugno 1931, una spedizione norvegese occupò la costa orientale della Groenlandia e battezzò l’area “Terra di Eirik Raudes”, dal nome di Erik il Rosso, un vichingo nato nell’attuale Norvegia che fu il primo europeo a raggiungere la Groenlandia nel 10° secolo.
Ernst Wolgast, professore di diritto internazionale che all’epoca insegnava a Rostock e Würzburg, aiutò la parte norvegese con pareri legali e con un’attività di pubbliche relazioni nei procedimenti davanti alla Corte permanente di giustizia internazionale (CIG) che seguirono il sequestro delle terre da parte della Norvegia. Nonostante l’aiuto dell’avvocato tedesco, tuttavia, la Corte si pronunciò a favore della Danimarca. Gli occupanti norvegesi si ritirarono quindi dalla Groenlandia orientale.[7] Il Ministro della Difesa di Oslo durante la crisi della Groenlandia orientale era Vidkun Quisling. Un mese dopo la sentenza della CIG Quisling fondò l’Associazione Nazionale di orientamento nazista (Nasjonal Samling, NS) e ne divenne il leader[8].
Seconda Guerra Mondiale
Dopo l’invasione tedesca della Danimarca nell’aprile 1940, il governo statunitense inviò una nave della Guardia Costiera americana in Groenlandia e aprì un consolato nella sua capitale, che allora si chiamava Godthåb (oggi Nuuk).
Gli Stati Uniti erano ancora neutrali all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, ma a causa dell’espansione tedesca in Europa, il governo di Washington estese rapidamente alla Groenlandia la Dottrina Monroe del 1823, concepita per l’America Latina e i Caraibi. Un mese dopo, anche il Canada aprì un consolato a Godthåb.[9] Dopo l’entrata degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, nel dicembre 1941, le truppe statunitensi occuparono la Groenlandia e stabilirono diverse basi militari lungo la costa. A Washington l’isola era vista come un importante pilastro della difesa del Nord America contro le truppe tedesche.
Dopo la fine della guerra, il governo statunitense offrì alla Danimarca 100 milioni di dollari come prezzo d’acquisto per l’isola, ma Copenaghen rifiutò.[10] Tuttavia, nel 1951 Washington riuscì a ottenere dal governo danese l’uso permanente della base militare di Thule, nel nord-ovest della Groenlandia. La base aerea di Thule divenne una delle basi di difesa aerea più importanti per l’aeronautica statunitense nell’emergente confronto tra blocchi.[11] L’Unione Sovietica ha sostituito la Germania come fattore più importante nella definizione della politica statunitense sulla questione della Groenlandia.
Flotte da pesca straniere
Ciononostante, la Germania ha continuato a influenzare la politica della Groenlandia. La pesca, estremamente importante per l’isola, ha svolto un ruolo centrale in questo contesto. Il conflitto interessò anche l’Islanda, che – a differenza della Groenlandia – era diventata indipendente nel 1944 dopo un lungo periodo di dominio coloniale danese. L’Islanda si impegnò allora a fondo per tenere lontani dalle sue acque i pescatori dell’Europa occidentale e in particolare quelli della Germania occidentale, che stavano saccheggiando in modo particolarmente pesante gli stock ittici islandesi.[12] Dopo lunghe battaglie, l’impresa ebbe successo: nel 1976 i pescatori d’altura tedeschi si ritirarono dall’Islanda.
La Groenlandia, invece, che non aveva ottenuto l’indipendenza ma era stata incorporata come provincia della Danimarca, è entrata a far parte del precursore dell’Unione Europea (UE) quando ha aderito alla Comunità Europea (CE) nel 1973. Tuttavia, da quando ha ottenuto lo status di autonomia nel Regno di Danimarca nel 1979, i groenlandesi sono stati autorizzati a decidere autonomamente su alcune questioni, come l’adesione alla CE. Nel febbraio 1980, le attività di pesca illegali dei pescatori tedeschi al largo delle coste della Groenlandia hanno provocato uno scandalo internazionale. I pescatori furono arrestati e condannati[13].
Ritiro dalla Comunità Europea
In Groenlandia, tuttavia, era iniziato un dibattito sull’uscita dalla CE, vista la straordinaria importanza dell’industria della pesca per la propria economia. In un referendum tenutosi nel febbraio 1982, il 53% degli elettori groenlandesi ha votato a favore dell’uscita. La politica della Groenlandia si è distinta dall’Europa occidentale non solo in termini di politica economica, ma anche di politica estera: a metà degli anni ’80, i parlamentari groenlandesi hanno istituito un organismo congiunto con i rappresentanti dell’Islanda e delle Isole Faroe, che dal 1997 si chiama “Consiglio nordico occidentale”. I membri del Consiglio hanno dichiarato la regione una zona denuclearizzata. Negli anni ’90, i politici groenlandesi si sono anche opposti alla costruzione di uno scudo missilistico della NATO, allora in progetto.[15] Il perseguimento della decolonizzazione definitiva e la crescente autonomia della Groenlandia hanno portato all’allontanamento politico dalla Germania.
Porta d’accesso all’Artico
Ciononostante, la Germania ha mantenuto delle leve indirette di influenza. Poiché il governo danese continua a essere responsabile della politica estera e di difesa dell’isola nonostante l’autonomia della Groenlandia, negli ultimi decenni il governo tedesco ha sempre fatto affidamento su una stretta collaborazione con la Danimarca sulle questioni artiche. Un esperto della Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), cofinanziata dal governo tedesco, ha descritto la Groenlandia come “la porta dell’Europa verso l’Artico”[16].
Se la Groenlandia diventasse indipendente, potrebbe aderire all’Associazione europea di libero scambio (EFTA) con l’Islanda e la Norvegia. Ciò garantirebbe un collegamento con l’UE anche senza appartenere alla Danimarca. Tuttavia, se la Groenlandia dovesse aderire agli Stati Uniti come territorio esterno o come Stato volontariamente associato, l’influenza dell’UE sarebbe ridotta al minimo.
Piani di annessione degli Stati Uniti
I piani degli Stati Uniti per conquistare la Groenlandia risalgono a molto tempo fa. Già durante la guerra civile statunitense (1861-1865), il Segretario di Stato degli Stati del Nord, William H. Seward (in carica dal 1861 al 1869), prese in considerazione l’acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti.[17] Sotto l’egida di Seward, gli Stati Uniti acquisirono l’Alaska dall’Impero Russo poco dopo la fine della guerra civile – a tutt’oggi la seconda più grande acquisizione territoriale nella storia degli Stati Uniti. [18] Nel 1867, i dipendenti del Coast Survey statunitense scrissero un rapporto completo sulla Groenlandia in cui, tra le altre cose, venivano descritte le risorse naturali dell’isola.[19]
Negli ultimi 160 anni, l’idea di un’acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti si è ripresentata più volte, anche poco dopo la Seconda Guerra Mondiale – e ora di nuovo dopo la prima presidenza di Donald Trump. La Cina è ora al centro della politica statunitense sulla Groenlandia. Dal 2017 Washington teme la crescente influenza della Cina sull’isola. L’influenza della Repubblica Popolare è stata finora limitata, e le aziende cinesi detengono solo quote di minoranza nelle società minerarie in Groenlandia a causa dell’influenza danese e statunitense[20]. Tuttavia, il governo autonomo della Groenlandia sta mostrando interesse nell’espandere le relazioni con la Cina: dal 2021 ha un proprio rappresentante nell’ambasciata danese a Pechino[21].
Rivalità militare
Nel 2019 gli Stati Uniti hanno tentato concretamente di acquisire la Groenlandia per la prima volta dopo decenni. Oltre alla battaglia per le materie prime e le rotte marittime geostrategicamente importanti dell’isola, si tratta sempre più di un’aperta rivalità militare.
NOTE:
- [1] Annette Christine Vogt: Un contributo di Amburgo allo sviluppo del commercio mondiale nel 19° secolo: Die Kaufmannsreederei Wappäus im internationalen Handel Venezuelas und der dänischen sowie niederländischen Antillen, Stuttgart 2003, pag. 249.
- [2] Gerhard Wiechmann: Die preußisch-deutsche Marine in Lateinamerika 1866-1914: Eine Studie deutscher Kanonenbootpolitik, Diss., Oldenburg 2000, p. 350.
- [3] Melvin Small: The United States and the German “Threat” to the Hemisphere, 1905-1914, in: The Americas, vol. 28 (1972), n. 3, pp. 252-270 (qui: p. 261).
- [4] Mark Nuttall: The Shaping of Greenland’s Resource Spaces – Environment, Territory, Geo-Security, New York (NY) 2024, S. 105.
- [5] B. W. Higman: A Concise History of the Caribbean, New York (NY) 2021, S. 255.
- [6] Janice Cavell: Historical Evidence and the Eastern Greenland Case, in: Arctic, Jg. 61 (2008), Nr. 4, S. 433-441 (hier S. 434).
- [7] Martin Moll: Chi erediterà Erik il Rosso? La disputa sulla Groenlandia 1920-1945 e il suo esito: dalla Corte dell’Aia al tentativo di revisione con la Germania di Hitler come partner, in: Robert Bohn (Ed.): Germania, Europa e Nord – Problemi scelti di storia dell’Europa settentrionale nei secoli XIX e XX, Stoccarda
- [8] Martin Kristoffer Hamre: Il fascismo norvegese in una prospettiva transnazionale: The Influence of German National Socialism and Italian Fascism on the Nasjonal Samling, 1933-1936, in: Fascism – Journal of Comparative Fascist Studies, Jg. 8 (2019), S. 36-60.
- [9] Nuttall: The Shaping of Greenland’s Resource Spaces, S. 106.
- [10] Piotr Szymański: Lotta in Groenlandia. Danimarca, Stati Uniti e Cina nella terra dei ghiacci, osw.waw.pl/en/ 02.03.2021.
- [11] Henry Nielsen/Kristian H. Nielsen: Camp Century – Città della guerra fredda sotto il ghiaccio, in: Ronald E. Doel/Kristine C. Harper/Matthias Heymann (Hgg.): Exploring Greenland – Cold War Science and Technology on Ice, Basingstoke 2016, S. 195-216 (hier: S. 198).
- [12] Ingo Heidbrink: Il colonialismo dimenticato di Brema: la pesca a distanza,, in: Norman Aselmeyer/Virginie Kamche (ed.): “Città delle colonie” – Come Brema ha plasmato il colonialismo tedesco, Friburgo in Brisgovia 2024, pp. 34-38 (qui: pp. 35/36).
- [13] Ove Johansen/Carsten Lehmann Sørensen: Greenland’s Way out of the European Community, in: The World Today, vol. 39 (1983), n. 7/8, pp. 270-277 (qui: p. 274).
- [14] Inizialmente l’Algeria faceva parte della CE a causa del suo legame con la Francia, ma è stata esclusa nel 1976. Su questo si veda: Megan Brown: The Seventh Member State – Algeria, France, and the European Community, Cambridge (MA)/Londra 2022.
- [15] Si veda Oltre l’UE.
- [16] Carsten Schymik: Greenland in self-government – The EU as an opportunity for the path to state independence. SWP-Aktuell 49, agosto 2009.
- [17] Dawn Alexandrea Berry: The Monroe Doctrine and the Governance of Greenland’s Security, in: Dawn Alexandrea Berry/Nigel Bowles/Halbert Jones (eds.): Governing the North American Arctic – Sovereignty, Security, and Institutions, London 2016, pp. 103-121 (qui: p. 107).
- [18] Michael A. Hill: Imperial Stepping Stone: Bridging Continental and Overseas Empire in Alaska, in: Diplomatic History, vol. 44 (2020), n. 1, pp. 76-101 (qui: p. 76).
- [19] Nuttall: The Shaping of Greenland’s Resource Spaces, p. 104.
- [20] Szymański: La lotta in Groenlandia.
- [21] Nuttall: The Shaping of Greenland’s Resource Spaces, p. 65.
La parte 1 di questa serie di articoli si può leggere al seguente link: La lotta per la Groenlandia (I)
Traduzione dal tedesco di Thomas Schmid. Rilettura di Anna Polo.