 Con 58 siti riconosciuti, 53 a carattere culturale e 5 a carattere naturale, l’Italia è il paese con più beni Unesco al mondo. Tutto bene? Esiste una tutela adeguata dei beni culturali, non subordinata a una visione mercantilistica? Di questo e altro, Francesca Valbruzzi, archeologa e saggista, discute con Carlo Pavolini, archeologo militante, per lungo tempo funzionario delle Soprintendenze di Ostia e di Roma e poi docente dell’Università della Tuscia, a partire dal suo ultimo libro, Quale valorizzazione (Robin Edizioni, Torino 2023). Un libro sui beni culturali, un’analisi critica delle riforme del ministro Franceschini_
Con 58 siti riconosciuti, 53 a carattere culturale e 5 a carattere naturale, l’Italia è il paese con più beni Unesco al mondo. Tutto bene? Esiste una tutela adeguata dei beni culturali, non subordinata a una visione mercantilistica? Di questo e altro, Francesca Valbruzzi, archeologa e saggista, discute con Carlo Pavolini, archeologo militante, per lungo tempo funzionario delle Soprintendenze di Ostia e di Roma e poi docente dell’Università della Tuscia, a partire dal suo ultimo libro, Quale valorizzazione (Robin Edizioni, Torino 2023). Un libro sui beni culturali, un’analisi critica delle riforme del ministro Franceschini_
Francesca Valbruzzi
Nel libro, Lei – che è un fautore della tutela “olistica”, cioè della compresenza in una Soprintendenza “unica” delle discipline dei beni culturali (archeologica, antropologica, architettonica, storico artistica) – mette in luce le contraddizioni del nuovo sistema statale di tutela, dove la tutela “contestuale” dei beni culturali viene affermata in teoria ma poi resa impraticabile nei fatti dalla separazione dei Musei e parchi archeologici dalle stesse Soprintendenze. Infatti, vengono indebolite la sfera di competenza e l’autonomia tecnica degli Enti di tutela per assoggettarli agli esecutivi. Sia in Sicilia che sul Continente le Soprintendenze “unificate” sono state private della gestione del Museo diffuso nei territori che dovrebbero tutelare. Davanti a questi esiti regionali e nazionali delle Soprintendenze uniche il nostro autore resta convinto delle sue tesi sulla tutela olistica?
Carlo Pavolini
L’idea iniziale di una tutela multidisciplinare e diacronica aveva alla base l’intento di far comprendere come un territorio pluristratificato qual è, per motivi storici, quello italiano non può essere governato separando in modo artificioso – ad esempio – le realtà archeologiche da quelle paesaggistiche e architettoniche, e così via. L’argomento principe che sottendeva la proposta – e che tuttora, a mio avviso, la rende valida – è culturale e metodologico.

Il difetto originario stava nel concepire il patrimonio storico-monumentale come un insieme di “cose” anziché come un insieme di relazioni e di rapporti: anziché come un contesto, per dirla con una parola. Del resto, di conservare le “cose” parlava esplicitamente ancora la legge 1089 del 1939, che per decenni ha avuto per certi versi una funzione positiva ai fini della salvaguardia, ma è anch’essa da storicizzare.
Tornando alla precisazione di cui parlavo, vedo quindi la tutela olistica come appannaggio delle professionalità della tutela che agiscono direttamente “sul campo”, sul territorio: quella archeologica, quella storico-artistica, quella antropologica e quella architettonica alla quale comunemente viene annessa la competenza paesaggistica. Spero sia chiaro che non considero certo meno importanti i bibliotecari o gli archivisti, preziosi perché presso di loro si vanno ad attingere dati e notizie da riversare poi nell’indagine sul terreno.
Se gli operatori dei settori che prima ho elencato, dirigenti e funzionari, ricevessero realmente una formazione aggiornata in senso interdisciplinare (per esempio tramite la Scuola del Patrimonio, ma qui il discorso si allarga), allora produrrebbe poi meno scandalo l’affidamento di una Soprintendenza territoriale unica ad un architetto anziché a un archeologo, e così via: mai, comunque, ad un amministrativo o a un manager, come pure è stato prospettato da alcuni, giustamente temuto da altri. Ma un simile esito catastrofico si può evitare formando, appunto, un ceto di operatori che siano in grado di governare il territorio con una visione unitaria, restando dei tecnici.
E in effetti, un simile cambiamento avrà successo solo a patto che venga conservato, e anzi potenziato, il bagaglio professionale e tecnico di ciascuna disciplina, in un quadro di equilibri che escluda furbesche scappatoie burocratiche, corporative o (peggio) clientelari, e ciò non sempre sta accadendo: ma di fronte ad alcune iniziali grida di allarme, non mi sembra affatto verificato il timore di una “distruzione” della tutela archeologica in Italia a causa dell’avvento delle Soprintendenze uniche.
Non vedo nemmeno il rischio di una “dittatura degli architetti”: e se pure tale rischio vi fosse, non vorrei che si trattasse di una quelle “profezie che si auto-avverano” a furia di parlarne, o del risultato di una scarsa chiarezza di idee da parte degli esponenti delle altre discipline. Costoro in effetti, quando affrontano l’argomento (parlo soprattutto degli archeologi), lo fanno spesso da una posizione difensiva e culturalmente datata, il che certo non giova. Ma è da ben altre cause che derivano i pericoli di un drastico deperimento della tutela nel nostro Paese.
Per tali aspetti rinvio al volume di cui stiamo trattando e al precedente mio libro del 2017, e rispetto alla mia posizione sulla Soprintendenza unica dico che la considero come la sola misura condivisibile (o quasi) fra le tante modifiche sostanziali introdotte dalle cosiddette “riforme Franceschini” nell’assetto amministrativo e giuridico del patrimonio. Misura condivisibile, ma malissimo applicata e – arrivo a dire – tradita proprio nel suo intento “olistico” dal contorno di quei provvedimenti (dovuti non solo a Franceschini stesso, ma, più in generale, ai governi dell’era Renzi) che per parte mia ho analizzato a sufficienza in quei testi, per cui non ci torno sopra.
Inoltre, nulla vieta di introdurre correttivi e integrazioni nel meccanismo delle Soprintendenze uniche, ad esempio affidando sistematicamente ogni pratica che riguardi (per dire) il parere su un piano paesistico con risvolti archeologici al funzionario architetto e a quello archeologo, in forma congiunta.
Credo che esperienze del genere siano state recentemente introdotte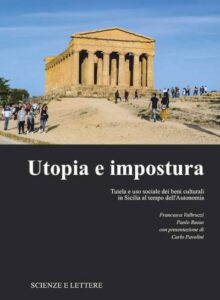 con successo in alcune Soprintendenze siciliane, uffici resi “unici” dalla coraggiosa e anticipatrice riforma regionale del 1977, poi anch’essa largamente tradita, vedi “l’utopia e l’mpostura” descritte nel bel libro omonimo di Valbruzzi e Russo (Utopia e impostura. Tutela e uso sociale dei beni culturali in Sicilia al tempo dell’Autonomia, Scienze e Lettere, 2019). E, per inciso, non mi sembra affatto che l’ala “marciante” e militante dell’archeologia siciliana chieda oggi un “ritorno all’antico”, cioè alla vecchia divisione per competenze, bensì un passo avanti e – finalmente – una reale attuazione dei presupposti della riforma del ’77.
con successo in alcune Soprintendenze siciliane, uffici resi “unici” dalla coraggiosa e anticipatrice riforma regionale del 1977, poi anch’essa largamente tradita, vedi “l’utopia e l’mpostura” descritte nel bel libro omonimo di Valbruzzi e Russo (Utopia e impostura. Tutela e uso sociale dei beni culturali in Sicilia al tempo dell’Autonomia, Scienze e Lettere, 2019). E, per inciso, non mi sembra affatto che l’ala “marciante” e militante dell’archeologia siciliana chieda oggi un “ritorno all’antico”, cioè alla vecchia divisione per competenze, bensì un passo avanti e – finalmente – una reale attuazione dei presupposti della riforma del ’77.
Certo, perché criteri come quello cui sopra accennavo funzionino, le Soprintendenze avrebbero bisogno una vera struttura interna per Dipartimenti, con mansioni chiare e affidate alle persone giuste (e quindi, di più concorsi, di più personale, di più risorse, eccetera): ed è soprattutto necessario che il Soprintendente – il quale ha, e deve conservare, il potere finale di firma – non si limiti a sommare passivamente i pareri dei suoi funzionari e a metterci il proprio timbro.
Se avviene questo, l’involucro esterno della riforma potrà anche sopravvivere, ma il suo svuotamento interno sarà alla lunga assicurato, mancando un effettivo lavoro comune (dei funzionari fra loro e con il dirigente), e mancando quella consapevolezza della natura contestuale del patrimonio che aveva motivato la prospettiva originaria della salvaguardia “olistica”.
Francesca Valbruzzi
Le “riforme Franceschini” hanno messo al centro il tema della “valorizzazione” del patrimonio culturale, o si è puntato su una visione puramente “mercantilistica” dell’uso dei beni culturali? Con la conseguenza di affidare la gestione delle grandi Istituzioni culturali a direttori manager per fare cassa e introitare cospicui profitti. Il libro esamina gli esiti delle “riforme Franceschini” sul sistema museale italiano, ponendosi una domanda cruciale: quali sono stati i presupposti culturali di questo processo? La tesi dell’autore, infatti, è che sia stata una ben precisa idea o “ideologia” di cosa debba essere la “valorizzazione” del patrimonio culturale a motivare l’azione politica e non il contrario, e la individua nella visione puramente “mercantilistica” dell’uso dei beni culturali. Si sarebbero così moltiplicati gli usi impropri, per fini di lucro, che gli Enti hanno fatto dei beni culturali a loro affidati, privatizzandoli come scenari del lusso sfrenato di danarose élite, in danno alla fruizione pubblica e alla loro integrità materiale e immateriale. In questo contesto, è evidente il rischio di dissipare il valore immateriale, simbolico del nostro patrimonio culturale: il cosiddetto “valore di esistenza” o “asset sociale”, come lo definisce il nostro Autore.
Carlo Pavolini
La risposta è immediata, è proprio così, ne stiamo dissipando tanto. Forse, anzi, di quell’essenziale valore simbolico e immateriale è ormai compromessa la maggior parte, e sia per tale aspetto, sia per gli altri, c’è poco da aggiungere a questo seconda riflessione di Francesca Valbruzzi.
Sono contento soprattutto che vengano colte, delle mie posizioni, due elementi che considero cruciali. Uno è la critica alla martellante propaganda circa una presunta “fine delle ideologie”, le quali, invece, non sono affatto morte: il problema è che, di fatto, attualmente ne è rimasta in campo una sola, quella “neo-liberista” (definizione magari schematica, ma calzante).
Secondo elemento: la priorità degli assunti culturali e, appunto, ideologici rispetto all’azione politica e amministrativa dispiegata – in materia di patrimonio – da Franceschini, o comunque ispirata da lui (e da Renzi). Alcuni “esperti del settore”, è vero, hanno fortemente sostenuto quegli assunti e quell’azione, contro altri che vi si sono opposti con altrettanta vigoria: ma è ugualmente vero che i grandi media, con un atteggiamento conformistico cresciuto nel tempo, hanno per lo più rinunciato ad ogni ruolo critico, limitandosi a definire “sensazionale” (ad esempio) ogni rinvenimento di area pompeiana, e per il resto riportando in modo meramente descrittivo le informazioni governative sui provvedimenti, le nomine, e via dicendo.
Che parte dell’opinione pubblica, in assenza di una reale politica di opposizione parlamentare e partitica (fatte salve alcune lodevoli eccezioni), sia stata sedotta da una narrazione che sbandierava la curva in salita della bigliettazione dei musei come unica prova della bontà della nuova gestione, era forse inevitabile: e tuttavia, sull’insieme di questi fenomeni di “consenso” – e sulle loro cause – riflettiamo forse troppo poco, mentre analizzarli a fondo ci aiuterebbe a contrastarli.
Mi sembra poi il caso di porre in luce un altro aspetto. Lo schieramento di destra che ci governa a partire dalle elezioni del 2022, e in esso il MiC a guida Sangiuliano, non sta facendo altro che proseguire sostanzialmente sulla linea dei predecessori “di sinistra”, in modo piuttosto meccanico e scarsamente creativo, o semmai introducendo alcune aggravanti. Ad esempio, con Sangiuliano gli uffici “dotati di autonomia speciale” sono diventati da 30 circa 60, e aumenteranno ancora (ci sarebbe da chiedersi: ma se piano piano tutto diventa “speciale”, che fine fa questa famosa “specialità”?). Si veda, inoltre, l’ondata di critiche sollevata dal riassetto operato da Sangiuliano sulle strutture centrali del Ministero, con l’aumento del numero dei Dipartimenti, ecc.
La malinconica conclusione è che il settennato franceschiniano, in questo senso, sembra aver posto le premesse per la deriva che abbiamo sotto gli occhi, ora che vige il “nuovo corso” di centro-destra: ma almeno Franceschini era dotato di esperienza parlamentare e politica, benché fosse portatore di una visione che ritengo sbagliata, mentre gli attuali esponenti del MiC (per lo più di origine giornalistica), quale autonoma strategia stanno mai esprimendo, al di là di una stanca ripresa della vecchia impostazione burocratico-ministeriale – ulteriormente appesantita – e al di là di una “valorizzazione” le cui forme si annunciano perfino peggiori di quelle fin qui note?
Su di esse non mi diffondo, e non ne elenco i tanti esempi possibili, perché l’ho fatto nel libro (certo in misura ben lontana dalla completezza), basandomi su cronache soprattutto giornalistiche mai smentite.
Inutile riparlare, quindi, delle sfilate di moda o delle nozze principesche all’interno di monumenti sottratti (a favore di un’élite del denaro e del potere) alla visita dei cittadini e dei turisti, o dei matrimoni nei templi greci, o delle gare di tiro con l’arco nei musei, o delle cene eleganti nelle biblioteche storiche (nelle quali, in teoria, non sarebbe consentito introdurre nemmeno una bottiglietta d’acqua): tutto al solo scopo di fare cassa.
Meglio passare alla possibile pars construens, che può consistere solo in un’azione di lunga lena in grado di porre finalmente – e davvero -la salvaguardia dell’eredità culturale come una delle grandi questioni irrisolte del Paese, accanto alla scuola, al Mezzogiorno o ai bassi salari, e di rango non minore, dato il peso eccezionale che la peculiare vicenda italiana assegna al patrimonio artistico e monumentale.
Purtroppo nessuno schieramento parlamentare (e in materia ci sarebbe anche da criticare la sostanziale sordità dei sindacati) sembra volersi intestare una simile strategia, e anzi, la disattenzione della politica riguardo a questi argomenti è forse ancor maggiore oggi che non nel passato. Eppure, a voler riassumere in poche frasi aspetti di enorme portata, la capillarità stessa delle presenze archeologiche e storiche nel nostro territorio farebbe sì che una messa in sicurezza di quest’ultimo (mediante quella manutenzione programmata sempre invocata, ma invano, da Giovanni Urbani) coinciderebbe con la messa in sicurezza del paesaggio naturale e umano tout court. Rappresentando, nel contempo, una grande occasione di lavoro per quelle forze intellettuali che sono oggi marginalizzate o relegate nel precariato (archeologi, storici dell’arte, architetti, antropologi, archivisti, bibliotecari, antropologi, archivisti e restauratori…), ma anche per maestranze operaie specializzate, da impiegare, ad esempio, nel recupero dell’edilizia storica.
In tal senso potremmo anche trovarci d’accordo con l’ironica smentita che Dario Franceschini, in forma di domanda retorica, ha scelto come titolo per il suo libro del 2022, con l’intento di rovesciare la celebre frase che Giulio Tremonti ha sempre negato di aver pronunciato (ma in tanti la pensano allo stesso modo). E cioè, in altri termini, “con la cultura si mangia” di sicuro, ma – se lo crediamo – il problema si sposta soltanto: per quale via, allora, trasformare la cultura, e i beni culturali, anche in un volano di sviluppo economico?
E’ il programma che a parole si prospetta da tanto tempo, ma del quale non si vede l’attuazione. Certo, l’arco delle forze e delle persone che si battono per la tutela e per una vera valorizzazione dell’eredità storica (opposta alla valorizzazione “mercatistica” e populista di cui s’è detto) devono guardarsi da un grande pericolo: quello di lasciarsi identificare con una minoranza di “spiriti eletti” e di paladini del patrimonio, animati da nobili intenzioni ma avulsi dalla realtà, e così via.
Non è vero, naturalmente, ma bisogna anche impedire che sembri vero, ed evitare di essere – di conseguenza – stretti in un angolo e definitivamente neutralizzati. Non ci sono ricette, ma forse bisognerebbe anzitutto riflettere sul fatto che l’attuale proliferazione di appelli e raccolte di firme (certo resa apparentemente più facile dall’esistenza del web) può produrre a lungo andare l’effetto opposto a quello voluto. La denuncia dei fatti più clamorosi o dei pericoli gravi e imminenti deve ovviamente continuare, ma, per non giocare solo in difesa, ad essa si deve affiancare una ripresa delle capacità di proposta politica, in forme che, di certo, sono ancora tutte da immaginare.
![]()
Beni culturali, tra sfruttamento ‘mercantile’ e necessità di un nuovo approccio










