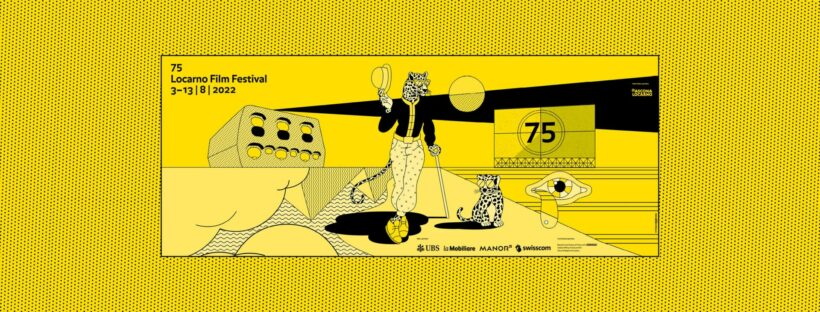Vittorio Agnoletto ha seguito per noi il Festival del Cinema di Locarno e come avviene ormai da diversi anni, ci racconta le sue impressioni e le riflessioni che ne scaturiscono. Gli articoli che da oggi seguiranno con cadenza giornaliera non sono dei testi di critica cinematografica, ma appunti, stimoli e pensieri che Vittorio condivide con i nostri lettori. Nelle prossime settimane alcuni di questi film usciranno in diverse città italiane che ospitano rassegne e festival. Buona lettura e … buona visione.
La 75° edizione del Festival del cinema di Locarno rappresentava una scommessa. Lo scorso anno il festival era stato in Svizzera il primo evento culturale a riaprire dopo la chiusura a causa della pandemia, ma dovendo rispettare le restrizioni dovute al rischio contagio era stata un’edizione ridotta.
La scommessa è stata vinta grazie alla capacità del direttore artistico Giona A. Nazzaro di coniugare la ricerca di un successo di pubblico e di cassetta con la presentazione di pellicole di buon livello culturale, capaci di affrontare importanti tematiche sociali e culturali, sottraendosi al richiamo delle sirene hollywoodiane. Questo intreccio ha riguardato principalmente i film in concorso e quelli presentati in piazza Grande, in genere nelle edizioni precedenti scelti prestando quasi un’esclusiva attenzione agli aspetti commerciali. Il pubblico e la critica sembrano aver gradito, premiando rispettivamente Last Dance e Annie Colère.
Annie Colère
Annie è un’operaia madre di due bambini; rimasta incinta desidera interrompere la gravidanza, ma nel febbraio del 1974 l’aborto in Francia era illegale. Il film Annie Colère della regista francese Blandine Lenoir, racconta l’incontro della protagonista con il MLAC, il Movimento per la Libertà dell’Aborto e della Contraccezione e la lotta che portò alla legalizzazione dell’interruzione di gravidanza con la legge voluta dalla ministra Simone Veil nel 1975. Un film assolutamente da non perdere, che ha meritatamente vinto il premio della critica, il Variety Piazza Grande Award. Il percorso di Annie è quello di una costante e progressiva presa di coscienza dei diritti delle donne e contemporaneamente del valore e della forza di un impegno collettivo.
Annie parte da un’esigenza personale, ma ben presto scopre, anche attraverso un evento drammatico che coinvolge una sua amica e per il quale sviluppa un senso di colpa, che la sua condizione è simile a quella di tante altre donne. Quello che inizialmente risulta essere motivo di vergogna, da nascondere e tacere, diventa situazione da condividere con le compagne di lavoro e in famiglia, dove l’impatto della sua crescita politica modifica, non senza fratture e incomprensioni, equilibri consolidati.
Il film insiste molto sulle caratteristiche dell’azione condotta dal MLAC, una realtà corale, dove le singole protagoniste si muovono come dentro un’orchestra, in un agire collettivo fondato prima di tutto sul mutuo soccorso. Donne attiviste, determinate, ma mai presentate come eroine, bensì come persone del loro tempo, che nella vita privata vivono esse stesse le contraddizioni contro le quali costruiscono il loro impegno sociale.
Qual è il rapporto tra la lotta per il riconoscimento legale dell’aborto e il conflitto di classe per un cambiamento complessivo della società? Quale il ruolo delle competenze professionali, in questo caso dei medici, in una campagna per l’ottenimento di un diritto che mette in discussione l’organizzazione stessa del mondo sanitario e il potere medico? Quando un’istituzione riconosce un diritto rivendicato da un movimento, in genere lo depotenzia, lo circoscrive e lo istituzionalizza. A quel punto quale può essere il ruolo del movimento? Sciogliersi, trasformarsi, costituire una realtà parallela a quella istituzionale, inserirsi nel percorso ufficiale e cercare di cogestire il diritto conquistato? Sono alcune delle domande che il film attraversa e alle quali dà qualche parziale risposta, lasciando per lo più aperti gli interrogativi. Interrogativi che, anche in Italia, da decenni ogni movimento deve/ha dovuto affrontare, compreso il movimento delle donne: dall’esperienza dei primi consultori autogestiti ai giorni nostri.
Le figure maschili restano sullo sfondo, sempre individuali senza mai riuscire a produrre un messaggio corale e il più delle volte incapaci, nonostante volenterosi e apprezzati sforzi, di comprendere fino in fondo il senso della lotta nella quale essi stessi svolgono un ruolo di co-protagonisti per scelta o per decisione della compagna.
Il film affronta in modo estremamente realistico e spiega nei particolari le fasi delle pratiche necessarie per interrompere la gravidanza, senza risultare mai brutale e senza presentare immagini troppo “forti”. La speranza è che possa presto apparire nei cinema italiani senza inutili polemiche. E’ un pezzo della nostra storia, italiana, europea e non solo, che dobbiamo conoscere e della quale è bene essere consapevoli, soprattutto in un momento storico nel quale dalle due sponde dell’Atlantico vi sono forti pressioni per cancellare una conquista che fino a poco fa ritenevamo acquisita per sempre.
Semret
Semret è una madre single eritrea che lavora all’ospedale di Zurigo; tenta in ogni modo di trasformare la sua vita in Svizzera nella propria normalità, rimuovendo il passato e sfuggendo alle domande della figlia adolescente sulle sue origini. Ma questo tipo di fughe o si concludono bruscamente e tragicamente o, prima o poi, ti presentano il conto, al quale non puoi fuggire. Ed è quello che accade alla protagonista.
Caterina Mona, la regista svizzera del film Semret, ha spiegato come la vicenda narrata non sia reale, ma sia composta da molte storie singole tutte vere; storie che lei ha ascoltato e raccolto nel quartiere di Zurigo nel quale ha ambientato la vicenda, che è quindi frutto di una lunga ricerca e di innumerevoli confronti con donne emigrate, ognuna portatrice di una specificità, destinata a trovare collocazione nella sceneggiatura e nell’ottima interpretazione di Lula Mebrahtu.
Semret desidera con tutte le proprie forze che la figlia sia e si consideri “svizzera” e quindi che non frequenti la comunità eritrea di Zurigo; desidera raggiungere uno status economico e sociale che rappresenti una cesura definitiva e insormontabile con il passato e sulla base di questo desiderio seleziona le amicizie, escludendo quelle che potrebbero riportarla ai ricordi dai quali continua a fuggire. Per raggiungere questo obiettivo è disposta a sacrificare i sentimenti, a vivere un’esistenza di solitudine ed anche ad abbandonare al proprio destino chi, provenendo da una storia simile alla sua, le chiede aiuto. Semret non è disposta a condividere con altre donne il proprio dolore, ad accettare un’elaborazione collettiva della tragedia che le ha coinvolte. Rimane lei, da sola, con il suo dolore.
Ma tutta questa fatica può crollare da un momento all’altro, per qualcosa di imprevedibile che si verifica ad esempio sul lavoro, o per l’impossibilità di cancellare dalla mente della figlia legittime domande sulla propria vita e sulle sue radici. Domande che, se restano senza risposta, rischiano di compromettere l’obiettivo finale di Semret.
La vicenda personale s’intreccia con la vita della comunità locale eritrea a Zurigo e con l’esistenza, sospesa nel tempo e nello spazio, di chi attende il permesso di soggiorno. Un film che non lascia indifferenti e che propone un punto di vista proveniente direttamente da chi vive il processo migratorio e il conseguente tentativo d’integrazione sociale. Certamente un punto di vista, non l’unico, ma che comunque ci aiuta a comprendere meglio la realtà di chi provenendo da lontano divide con noi la quotidianità.
Un film che potrebbe essere utile come strumento di riflessione, anche per le stesse comunità che hanno vissuto direttamente il fenomeno migratorio.
Last Dance
Last Dance, della regista svizzera Delphine Lehericey, ha meritatamente vinto il Premio del pubblico. Un film su un tema difficile come la vecchiaia, ma capace di leggerezza e di divertire, grazie a un’idea originale dalla quale prende spunto la storia. In questo caso il protagonista è un uomo, ma impegnato in un difficile tentativo di emulazione di una donna.
Due anziani coniugi si sono promessi che chi fra loro due sopravvivrà dovrà portare a termine le attività praticate dall’altro prima del decesso. A differenza di quanto previsto sarà Germain, un pensionato di 75 anni, a sopravvivere all’improvvisa morte della moglie, ballerina di danza contemporanea in uno spettacolo in allestimento. Germain dovrà prenderne il posto nella recita. Nel frattempo, i suoi figli cercano di organizzargli minuto per minuto l’esistenza, prendendosi cura di lui in modo asfissiante, intrufolandosi nella sua vita quotidiana con continue telefonate, visite improvvise e prescrizioni varie.
Germain prova a trasformarsi in ballerino all’insaputa dei famigliari, provocando un susseguirsi di situazioni destinate a suscitare il divertimento del pubblico. Ma Last Dance non fa solo sorridere. Sullo sfondo del film vi sono infatti temi importanti e attuali: la terza età proposta come spazio possibile per una vita ancora attiva; un desiderio di accudimento che può soffocare e indebolire il destinatario ignorando, anziché potenziando, le sue risorse residue. In sintesi, un film che divertendo, stimola qualche utile riflessione.
Une femme de notre temps
Une femme de notre temps del regista francese Jean Paul Civeyrac è un film che non stimola grandi riflessioni, ma ben realizzato. La protagonista, come accade spesso in questa edizione del festival, è una donna con una forte etica personale, Juliane, commissaria di polizia a Parigi. La scoperta della doppia vita del marito metterà a dura prova i suoi principi. Film d’azione destinato a piacere al grande pubblico.