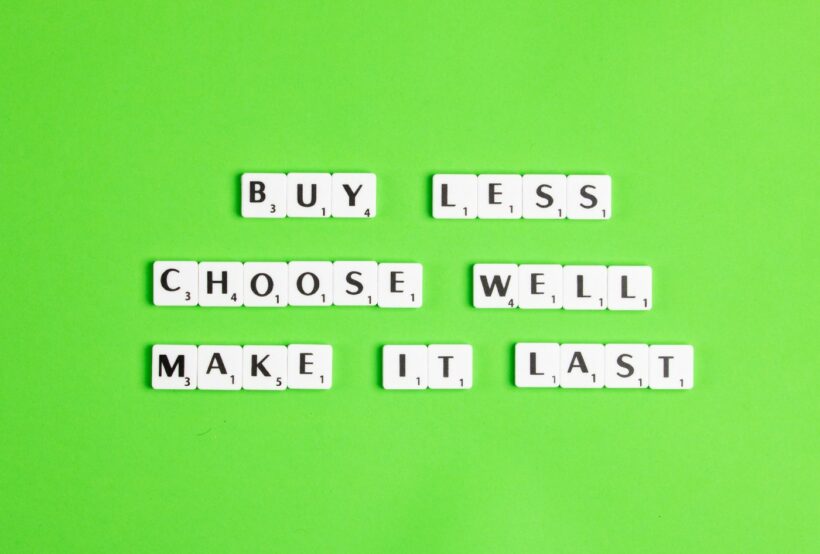Già nel XVI secolo lo scrittore svizzero Gottfried Keller sapeva che gli abiti fanno l’uomo (è sua la novella con questo titolo, N.d.T.). Tuttavia, ciò che forse non viene subito in mente a molti è il fatto che gli abiti, o più in generale il modo in cui vengono prodotti, consumati e smaltiti, “fanno” molto di più: dalle violazioni dei diritti umani ai danni ambientali, per esempio. Diana Sanabria, che lavora proprio su questo tema come consulente di economia globale, fornisce preziose indicazioni.
Grazie Signora Sanabria per aver trovato il tempo di parlare con Pressenza dell’industria tessile mondiale, che viene spesso criticata. Numerosi rapporti di varie organizzazioni per i diritti umani, ad esempio, descrivono gli abusi che prevalgono nei “regimi di sweatshop” [vedere note], che si trovano principalmente nei Paesi in via di sviluppo. Che cosa si intende esattamente?
In sostanza, lo sweatshop è un regime in cui i lavoratori e le lavoratrici operano in condizioni precarie. Spesso tali regimi sono situati in Paesi in cui il controllo statale sull’osservanza delle norme giuridiche è quasi inesistente, ammesso che esistano norme giuridiche in materia di lavoro o ambiente.
Perché esistono questi regimi?
I regimi di sweatshop esistono perché l’attuale sistema economico li consente. Un sistema economico orientato al profitto e preferibilmente privo di regolamentazione degrada i diritti umani e le conseguenze dannose per l’ambiente a esternalità, il che significa che le persone e l’ambiente sostengono i costi generati dalle imprese.
Può fare un esempio concreto? In che misura queste forniscono spazio alle violazioni dei diritti umani?
Un esempio concreto è rappresentato dai salari. Prendiamo una fabbrica che produce per un marchio di moda europeo. Questo marchio vuole acquistare nel modo più economico possibile, il che significa che i produttori che vogliono ottenere un ordine devono fare l’offerta più conveniente. I costi vengono esternalizzati pagando salari da fame ai lavoratori impiegati a questo scopo. Questo sfruttamento sistematico è reso possibile da diversi sistemi legali in tutto il mondo.
Un salario da fame significa che si può vivere con quello?
No, non necessariamente e spesso anche un salario minimo stabilito per legge è un salario da fame. In paesi come la Colombia, l’India o il Pakistan, ad esempio, dove il governo ha fissato un salario minimo, questo non è sufficiente per pagare l’alloggio, nutrirsi o permettersi l’istruzione e l’assicurazione sanitaria. Di conseguenza, le famiglie scelgono di risparmiare sull’alimentazione per pagare, ad esempio, i costi dell’istruzione dei figli.
Quali altri casi di violazione concreta dei diritti umani sono causati da questo sistema?
Le violazioni dei diritti umani in questo campo sono molteplici. Per esempio, stiamo parlando del lavoro minorile nelle piantagioni di cotone, della violenza o delle molestie sessuali lungo la catena di approvvigionamento. Bisogna considerare che circa l’80% dei lavoratori dell’industria tessile sono donne. Poi si parla anche di orari di lavoro che non sono affatto in linea con quelli considerati consensuali dalla legge o a livello internazionale. In alcuni casi si tratta di lavoro forzato, di rischi per la salute e di restrizioni alla libertà di associazione.
Perché l’industria tessile mondiale si è sviluppata in questa direzione?
Ciò è dovuto principalmente al fatto che le aziende, in quanto persone giuridiche, sono associate a molti privilegi che non si riflettono necessariamente nella società. Ad esempio, le aziende si preoccupano del vostro contributo al bene comune della società? Con questo non intendo solo la società in cui ha sede un’azienda, ma tutte le persone che sono in qualche modo collegate alle attività dell’azienda: lavoratori in Bangladesh, clienti in Germania o agricoltori in una piantagione di cotone in Brasile. Alcuni si assumono questa responsabilità volontariamente, mentre altri reagiscono solo in presenza di obblighi legali. In molti casi, i profitti continuano ad essere messi al di sopra di tutto. Ma è davvero sempre per il bene di tutti?
I diritti umani sono una cosa. Ci sono anche altre aree che ne risentono negativamente?
Anche se si tende a non collegarle direttamente, le conseguenze ambientali dell’industria tessile sono devastanti. Nell’industria dell’abbigliamento, ad esempio, vengono utilizzate molte sostanze chimiche pericolose per garantire una certa qualità del tessuto. Il loro scarico nei fiumi vicini distrugge gli ecosistemi. Inoltre, il consumo di acqua per la produzione degli indumenti è un problema. Una sola maglietta consuma circa 2.700 litri d’acqua. Se pensiamo che ogni anno si vendono 80 miliardi di capi di abbigliamento e se ne producono molti di più, possiamo immaginare quanta acqua sia necessaria per questo. Un altro punto riguarda le emissioni di gas serra causate dall’industria tessile, che si stima sia responsabile del 10% delle emissioni globali di CO2. Si tratta di una quantità superiore a quella prodotta dal trasporto aereo e marittimo messi insieme. Ma l’aspetto probabilmente più sconvolgente riguarda i rifiuti di abbigliamento. Stiamo parlando di 92 milioni di tonnellate all’anno, ossia tre tonnellate al secondo. Questo è uno scandalo.
Paradossalmente, questo impatto non influisce sulla domanda globale di abbigliamento. Perché?
Non mi piace parlare di necessità in questa sede. Molte persone comprano vestiti non perché ne hanno bisogno, ma perché li desiderano. Questo va di pari passo con la cosiddetta pseudo-democratizzazione del privilegio di indossare abiti eleganti, promossa da azioni di marketing mirate che convincono i / le potenziali acquirenti che anche loro possono e vogliono apparire privilegiati. Questo, insieme alla mancanza di informazioni sugli abusi nell’industria tessile, porta in ultima analisi a un elevato consumo di abbigliamento.
Questo significa che la responsabilità principale è dei clienti che non si informano a sufficienza?
Parte della responsabilità è dei /delle clienti. È necessario informarsi attraverso il Fashion Checker, ad esempio. Tuttavia, non dobbiamo commettere l’errore di addossare frettolosamente ai clienti la responsabilità principale del consumo sostenibile. Chi si informa davvero prima di ogni acquisto? Soprattutto se si considera che le informazioni spesso non sono liberamente disponibili e che le aziende sono in ultima analisi responsabili della produzione di abbigliamento, esse devono essere maggiormente responsabilizzate.

Illustrazione: “Cara Europa, puoi responsabilizzare le imprese in modo che i diritti umani vengano rispettati?” – “Si, l’EU può!” – Legge europea https://lieferkettengesetz.de/en/
Che ruolo hanno gli attori politici in questo caso?
La maggior parte delle aziende non si considera responsabile di agire in assenza di norme. Tuttavia, i diritti umani e ambientali necessitano di una protezione efficace, che solo le normative possono fornire. Un buon esempio è l’industria farmaceutica. Non è possibile vendere alcun farmaco senza soddisfare determinati requisiti. È proprio questo il punto in cui entrano in gioco gli attori politici, poiché le imprese non amano internalizzare i costi esternalizzati. Un buon esempio di normativa che si propone di fare proprio questo è il Supply Chain Act, che include diverse norme per proteggere i diritti umani e ambientali lungo la catena di approvvigionamento (Proposta di direttiva del Parlamento Europeo relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, N.d.T.)
Sono assolutamente d’accordo. Grazie per gli interessanti approfondimenti sull’industria tessile e auguri per il suo futuro lavoro!
1] Mezzadri, A., (2016). Il regime delle fabbriche di sudore. Regno Unito: Cambridge University Press.
2] Tallon, E., (2018). La tragedia dei beni comuni. Disponibile presso: https://amnesty.sa.utoronto.ca/2018/10/17/tragedy-of-the-commons-the-danger-behind-the-fast-fashion-industry/.
3] N.d., (2021). Diritti del lavoro nell’industria dell’abbigliamento. Disponibile presso: https://www.hrw.org/topic/womens-rights/labor-rights-garment-industry.
Traduzione dal tedesco di Thomas Schmid. Revisione di Filomena Santoro.